
Capacità, fragilità, fraternità: rileggendo Martha Nussbaum
Intervista a Fiammetta Ricci in vista del suo intervento al Festival di Bioetica (Rapallo, 29 e 30 agosto)
 Sabato, 16/08/2025 - Quando si parla di 'Fraternità' dal punto di vista della bioetica entrano in campo, a ragione, anche richiami alla filosofia. In questa cornice si dipana il contributo che Fiammetta Ricci - ordinaria di Filosofia politica all'Università di Teramo - porterà al Festival di Bioetica (Istituto Italiano di Bioetica - Rapallo, 29 e 30 agosto) ispirandosi al pensiero di Marta Nussbaum sul tema della cura in relazione alla 'Fraternità', che è il focus della nona edizione del Festival.
Sabato, 16/08/2025 - Quando si parla di 'Fraternità' dal punto di vista della bioetica entrano in campo, a ragione, anche richiami alla filosofia. In questa cornice si dipana il contributo che Fiammetta Ricci - ordinaria di Filosofia politica all'Università di Teramo - porterà al Festival di Bioetica (Istituto Italiano di Bioetica - Rapallo, 29 e 30 agosto) ispirandosi al pensiero di Marta Nussbaum sul tema della cura in relazione alla 'Fraternità', che è il focus della nona edizione del Festival. Su quali elementi si è soffermata, in particolare, nel preparare il suo contributo al Festival?
Ho scelto di declinare il tema del Festival di Bioetica di questa edizione 2025 attraverso un paradigma lessicale “capacità, fragilità, fraternità” tratto dalla rilettura di alcune opere di Martha Craven Nussbaum, filosofa e saggista statunitense che offre molteplici spunti di riflessione sull’argomento. Teniamo presente, ad esempio, che Nussbaum reagisce alle teorie di matrice liberista che considerano l’individuo non come persona, cioè come fine in sé, ma solo nell’ottica di un suo apporto meramente “produttivo” alla società. In questa prospettiva, nella rappresentazione cioè della persona umana considerata come mezzo per la produzione, le capacità umane e le relazioni umane risultano puramente strumentali e non fondative del riconoscimento di una comune condizione umana di mutuo accudimento, cura, responsabilità, accoglienza e, dunque, fraternità.
Marta Nussbaum esplora il concetto di 'Fraternità' come modello nelle relazioni e nella cura?
Sebbene Martha Nussbaum non utilizzi esplicitamente la parola fraternità, i suoi lavori sono permeati, in un modo o nell’altro, dalla proposta teoretica ed etico-politica di uno sviluppo umano che tenga conto dell’uguale condizione umana di vulnerabilità e fragilità dell’esistenza, e che sia volto, per dirla sinteticamente, al superamento delle diseguaglianze e delle ingiustizie sociali in forza di un nuovo sguardo sulle relazioni umane e sulle capacità (le capabilities) di ogni persona. Questa tensione etica, politica ma anche sociale e pedagogica, si sostanzia in un approccio, ormai noto come capability approach, inteso come proposta teorica, ma anche pragmaticamente realizzabile, di un principio normativo fondamentale per il riconoscimento dei diritti umani da parte dei singoli e da parte dei governi. In questa premessa di fondo si apre una via percorribile e fattuale non solo alla riarticolazione tra giustizia e dignità umana, come titola uno dei suoi libri, ma anche la possibilità di una relazione umana che si iscrive nella fraternità universale, fondata sul riconoscimento del valore umano di ogni persona, dotata di capacità e di funzionamenti per il fine di quella vita buona, di quel principio e ideale di bene comune, a cui hanno diritto tutti gli esseri umani e, voglio aggiungere, tutti gli esseri viventi. Come scrive Martha Nussbaum, solo attraverso “compassione” e “amore” riusciamo a cogliere e a rispondere alla vulnerabilità dell’altro e al suo bisogno esistenziale di cura, in special modo con condizioni di disabilità, o in società dove il multiculturalismo e le differenze di genere determinano intolleranza, emarginazione e discriminazione. Il tema della cura come impegno etico e politico è di centrale importanza per la Nussbaum; e l’etica della cura deve farsi politica della cura per il superamento di ogni forma di ingiustizia e di sopraffazione, e quindi per sostituire alla “politica del disgusto” la “politica dell’umanità”.
Quali sono le opere di Nussbaum che ritiene particolarmente significative nell'ambito tematico del suo intervento?
Tra le opere di Martha Nussbaum, come non citare La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia greca, in cui, attraverso il costante dialogo con i filosofi antichi e moderni, è centrale il concetto di vulnerabilità considerato come la chiave per la realizzazione del bene fra gli uomini; anche in Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea riprende e approfondisce quei temi ancora partendo da una lettura attenta e problematica dei classici greci per arrivare ad analizzare e definire alcuni concetti fondamentali per la condizione umana: il dolore, la compassione, l’amore e, successivamente, il disgusto e la vergogna (non dimentichiamo appunto l’opera Nascondere l’umanità. Il disgusto e la vergogna), tenendo sempre in mente il rapporto delicato e complesso tra la singolarità degli individui e l’universalità dei principi. C’è infatti una Intelligenza delle emozioni, come titola un altro dei suoi più noti libri, che è essenziale per la vita sociale e politica e per le relazioni umane. Tra le emozioni analizzate, l’autrice si concentra sul ruolo che l’amore può assumere nella costruzione di una società liberaldemocratica e nel suo sviluppo sociale. Riconoscere e promuovere le libertà funzionali, ossia le capacità umane personali, è la base per una autentica giustizia sociale. Ricordiamo le sue battaglie per le minoranze, per i senza voce, e per le donne. E se in Diventare persone. Donne e universalità dei diritti appare più esplicito il suo impegno per la condizione femminile, in realtà anche nelle altre opere emerge sempre un riferimento ed una richiamo ai problemi connessi con la violazione dei diritti delle donne. Nell’opera Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, si coglie chiaramente che lo scopo della giustizia deve essere quello di garantire che la dignità di ogni essere umano si incarni nelle pratiche e si realizzi nelle istituzioni di cooperazione sociale. E il ruolo della teoria politica è di conferire la struttura formale e la giustificazione dei princìpi che possano concretizzare socialmente tale giustizia. La fraternità dunque è possibile se vengono riconosciute, tutelate e promosse le diverse culture, accettandone le peculiarità senza metterle in discussione in base a presunte superiorità del pensiero occidentale.
Quali concetti sono alla base di questo approccio che possiamo collegare con il tema della Fraternità?
Insomma,Nussbaum ripropone, mutuandola dal pensiero di Aristotele, il tema dell’eudaimonìa, cioè della “prosperità umana”, come cardine intorno al quale ruotano la capacità cognitiva umana e la riconsiderazione della sfera delle emozioni che orientano le persone alle scelte etiche e le rendono più attente alle proprie aspettative, e a considerare quelle degli altri. Questa prospettiva propone un’etica globale che abbia valore universale per la società civile e riaffermi i postulati per una convivenza civica democratica. Ecco perché, in sintesi, la teoria delle capabilities (condizioni minimali e libertà di base “che devono essere socialmente garantite affinché un individuo possa impegnarsi in attività umane degne di rispetto”) si fonda sulla conoscenza e valorizzazione della natura e della fragilità umana, assi portanti di qualunque possibile e concreta fraternità, nel senso più ampio, complesso e profondo della parola.
Intervista a cura di Tiziana Bartolini
.jpg)
Scarica il PDF
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®








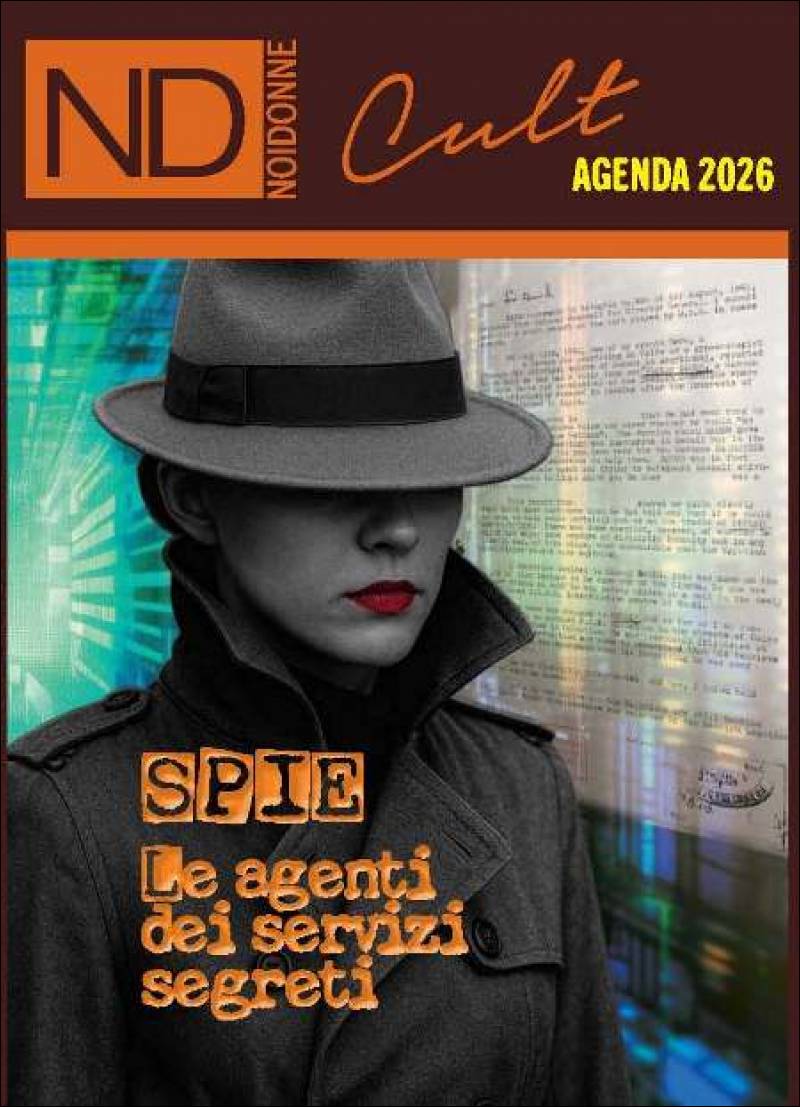
Lascia un Commento