
Cittadine a metà: le elezioni regionali e la rappresentanza di genere - di Barbara Bonciani
Nelle Marche, in Calabria e in Toscana il numero delle donne elette nei consigli regionali è diminuito rispetto al quinquennio precedente. Stiamo tornando indietro?
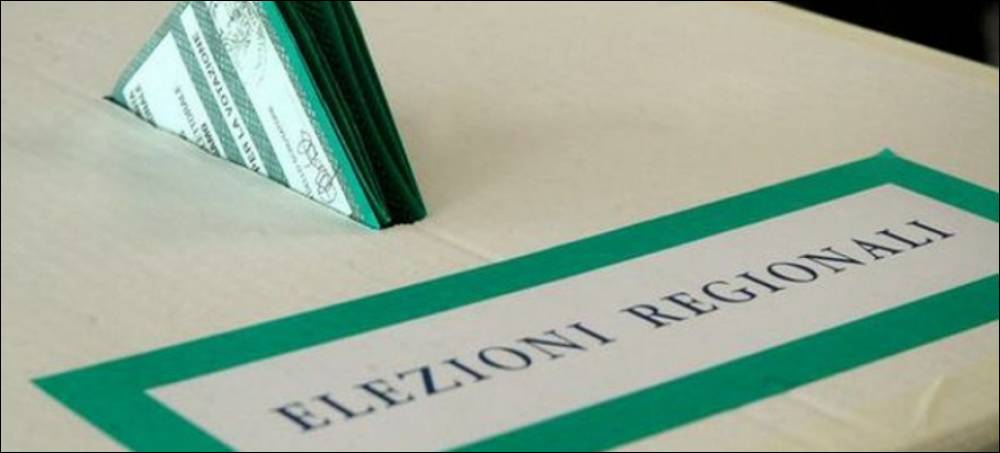 Mercoledi, 29/10/2025 - Nel 2012 la sociologa Chiara Saraceno, nel libro edito da Rizzoli “Cittadini a metà” spiegava come i divari salariali tra uomini e donne nel nostro Paese sono più elevati rispetto agli altri Paesi europei e come le donne siano di fatto escluse dai ruoli di potere. Più di dieci anni dopo, i risultati delle elezioni regionali mostrano come, la tendenza all’esclusione delle donne dai ruoli di potere non sia ancora sanata e che per le donne il percorso verso l’elezione è più in salita rispetto agli uomini.
Mercoledi, 29/10/2025 - Nel 2012 la sociologa Chiara Saraceno, nel libro edito da Rizzoli “Cittadini a metà” spiegava come i divari salariali tra uomini e donne nel nostro Paese sono più elevati rispetto agli altri Paesi europei e come le donne siano di fatto escluse dai ruoli di potere. Più di dieci anni dopo, i risultati delle elezioni regionali mostrano come, la tendenza all’esclusione delle donne dai ruoli di potere non sia ancora sanata e che per le donne il percorso verso l’elezione è più in salita rispetto agli uomini.Nelle Marche, in Calabria e in Toscana il numero delle donne elette nei consigli regionali è diminuito rispetto al quinquennio precedente. Le donne elette nel Consiglio regionale della Toscana sono 9 su 40 (7 in meno rispetto al 2020), mentre nelle Marche risultano 6 su 30 (2 in meno rispetto al 2020), in Calabria sono 7 su 31 (una meno rispetto al 2020).
Parliamo di tre regioni dove le donne rappresentano poco più del 51% della popolazione residente; siamo dunque a circa il 20% di rappresentanza femminile. Inoltre, non c’è nessuna candidata donna alla Presidenza delle regioni che sono già andate al voto, tantomeno in quelle che voteranno nell'autunno 2025.
Stiamo tornando indietro? E cosa c'è da imparare dalle recenti elezioni regionali in termini di pari opportunità di accesso alla politica? Vedremo quali saranno i dati delle elette nelle prossime tornate elettorali regionali, tuttavia, la tendenza emersa fino ad ora non è incoraggiante e dovrebbe impegnarci almeno a cercare cause e soluzioni, al fine di onorare e rispettare i principi costituzionali di parità e uguaglianza.
La Costituzione della Repubblica democratica italiana, infatti, non solo afferma l’uguaglianza “senza distinzione di sesso” nei suoi principi fondamentali (art. 3), ma fin dall’origine contiene norme espressamente volte a garantire il principio delle pari opportunità uomo-donna in materia elettorale (art. 48 e 51), che la revisione costituzionale degli articoli 117 nel 2001 e 51 nel 2003 ha reso ancor più esplicito. Evidentemente tutto questo non basta perché il principio di eguaglianza si traduca effettivamente nella realizzazione di una democrazia paritaria. Per questo è importante comprendere le ragioni della flessione delle elette nelle regioni in cui si è votato, oltre alle motivazioni alla base della mancanza di donne candidate ai vertici delle istituzioni regionali.
L’analisi del fenomeno non è semplice e necessiterebbe di un’indagine conoscitiva approfondita, capace di tenere insieme tanti aspetti, fra cui: le dinamiche interne ai partiti, la difficoltà sperimentata dalle donne nel trasformare i voti in rappresentanza concreta, oltre che l’influenza esercitata dalla società patriarcale in cui viviamo sul voto degli elettori in termini di preferenza.
Che i partiti siano strutture di potere tendenti all’auto-conservazione lo scriveva già il sociologo Max Weber nella sua opera “Economia e società” nel 1922, mettendo in rilievo come, l’obiettivo di ottenere e mantenere il potere, di fatto può creare una chiusura interna, che può portare i partiti a concentrarsi più sulla propria sopravvivenza e sul loro consolidamento, che sugli obiettivi inziali. Questa inclinazione alla chiusura che noi in tempi contemporanei possiamo definire come tendenza all’auto-referenzialità e alla conservazione favorisce, ancora oggi, una distribuzione diseguale del potere a vantaggio degli uomini. A tal proposito, basterebbe contare il numero delle donne collocate con ruolo nelle posizioni di vertice degli organismi dei partiti politici per capire a che punto siamo, tenendo conto del principio “Sacrosanto” più volte enunciato da Michela Murgia secondo il quale, finché le donne non contano è necessario contarle per documentare la loro presenza o mancanza, in modo da renderle visibili ed evidenziare le disuguaglianze.
Sappiamo che i partiti sono in grado di influenzare il voto e le preferenze degli elettori e che generalmente gli sforzi vengono concentrati sui capilista.
Se guadiamo la composizione delle liste in Toscana ci accorgiamo che su 138 capolista complessivi, 91 erano uomini e 47 donne. Partiamo quindi da un dato di partenza poco bilanciato sul piano dell’appartenenza di genere che si è riversato poi sulla rappresentanza. Nelle elezioni toscane, infatti, i candidati e le candidate hanno ottenuto 851.139 preferenze totali. Di queste, il 60% (510.686) sono state ottenute dai candidati uomini, mentre il 40% (340.453) sono andate alle donne. Se si confrontano i voti espressi con l’effettiva elezione in Consiglio regionale si nota come, rispetto al consenso ottenuto, le donne abbiano sperimentato una distribuzione di seggi sbilanciata.
I consiglieri uomini eletti sono infatti 31 (il 77%), mentre le donne sono 9 (il 22,5%).
In sostanza, le donne sperimentano maggiori difficoltà a trasformare i voti presi in rappresentanza effettiva, seppur il loro contributo all’esito elettorale dei partiti di appartenenza sia molto significativo.
Se è vero che la legge elettorale obbliga l’alternanza di genere nella composizione delle liste e prevede, in alcune regioni, come per la Toscana, la possibilità per l’elettore di dare una doppia preferenza votando un uomo e una donna, tutto questo non è risultato sufficiente, di per sé, a favorire una maggiore rappresentanza femminile.
Per questo sarebbe importante definire criteri e strumenti correttivi, in grado di trasformare i voti in rappresentanza concreta.
Per ultimo, ma non meno importante, assume rilevanza la capacità della società patriarcale in cui viviamo di influenzare il voto di preferenza.
Dobbiamo considerare, infatti che le scelte elettorali in termini di preferenza di genere, sono il riflesso anche la società in cui viviamo. La nostra società patriarcale è ancora intrisa di stereotipi e pregiudizi tali, da far riconoscere ancora nelle donne, il gruppo sociale con minori caratteristiche necessarie a ricoprire ruoli di leadership, rispetto agli uomini.
Significativa in questo senso è una ricerca di Ranstad del 2016 in cui alla domanda “preferisci un capo uomo o una donna?” gli uomini sono risultati preferiti per il 65%. I dati di questa indagine, seppur riferiti al mondo lavorativo fanno ben capire come, lo specchio della società in cui viviamo, in cui gli uomini di fatto ricoprono in maggioranza i ruoli di leadership aziendale e politica, è in grado di influenzare ancora e in modo significativo una parte dell’elettorato sulla scelta del voto di preferenza. Sono infatti ancora poche le donne che svolgono o hanno svolto ruoli apicali in ambito politico e spesso, come è accaduto in Toscana, le donne che lo hanno fatto vengono riconosciute, apprezzate e votate di più.
La tendenza negativa sperimentata dalle donne nelle elezioni regionali fa capire come non basti avere una Presidente del Consiglio donna o una Segretaria del principale partito di sinistra donna, per promuovere una maggiore rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche.
La strada da percorrere è ancora in salita e richiede un percorso plurale e partecipato dal basso, capace di attivare e dedicare spazi e tempi di discussione e confronto su un tema di democrazia e giustizia sociale come quello della rappresentanza femminile. Sarà quindi necessario unire gli sforzi, come uomini e donne, per comprendere a fondo le ragioni della riduzione della componente femminile nella rappresentanza politica, studiando azioni positive in grado di favorire un’inversione di tendenza per il futuro.
Barbara Bonciani
Sociologa, docente dell’Università di Pisa
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®


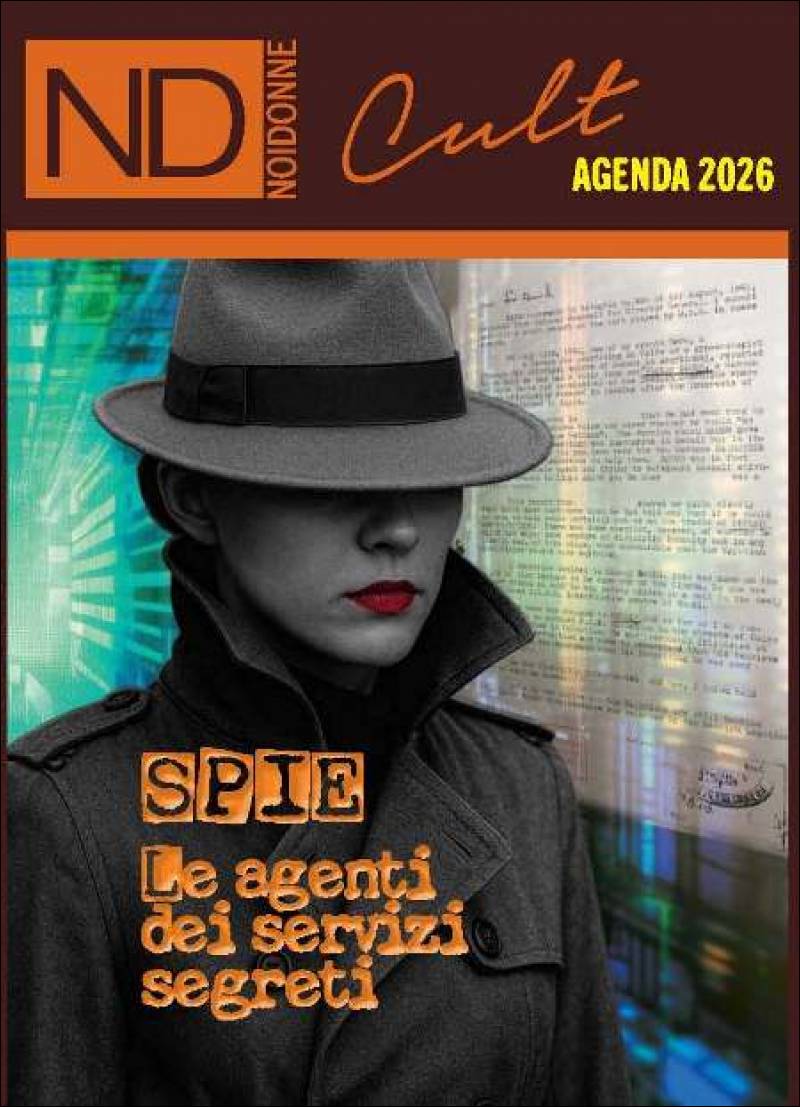

Lascia un Commento