
Giovani tra social media e affettività: quale 'Fraternità'? Intervista a Enzo Baldini
Internet, il web e i social media sono nati per connettere persone invece hanno generato isolamento e solitudine. Autorevoli studi parlano di danni molteplici a livello fisico e comportamentale
 Lunedi, 18/08/2025 -
Lunedi, 18/08/2025 -
Con una relazione dal titolo "Giovani e social media: tra 'amicizia', rapporti affettivi e solitudine" nell'ambito del Festival di Bioetica organizzato dell’Istituto Italiano di Bioetica (Rapallo 29 e 30 agosto) Enzo Baldini - componente del Comitato scientifico e professore di Storia del Pensiero politico all'Università di Torino - affronta il delicato e attualissimo tema dell'impatto che hanno i social media sulle giovani generazioni.
Il suo intervento al Festival di Bioetica, facendo riferimento ad alcuni tra i più recenti studi anche di carattere internazionale, pone l'attenzione sui danni che l'uso dei cellulari sta provocando nello sviluppo cognitivo e affettivo delle giovani generazioni. Può anticipare, sinteticamente, i problemi che porrà all'attenzione del pubblico durante il prossimo Festival di Bioetica?
È ormai accertato in termini scientifici che l’uso precoce dello smartphone produce nei giovani danni molteplici sia di ordine fisico (modificazione della struttura cerebrale) che comportamentali, soprattutto perché si combina col dirompente impiego dei social media e dell’intelligenza artificiale. L’abuso del cellulare compromette inoltre il rendimento scolastico, diminuisce la capacità di attenzione e di concentrazione, riduce la creatività, favorisce conformismo di pensiero e aumenta, tra l’altro, l’isolamento sociale, sostituendo le interazioni reali con quelle virtuali. Recenti ricerche hanno poi attestato che, con l’avvento di ChatGPT (novembre 2022), l’intelligenza artificiale veicolata dagli smartphone ha persino contribuito a modificare i codici espressivi, spingendo le persone verso una forma di linguaggio più standardizzato e prevedibile.
Con smartphone e supporti digitali, gli adolescenti e i giovani si rifugiano sempre più in un mondo virtuale. Ma le interazioni coi coetanei tramite tecnologie digitali non sono certo in grado di sostituire le indispensabili esperienze fisiche e sociali del mondo reale, necessarie per sviluppare competenze di base, quali, ad esempio, le ‘relazioni corporee’ in cui usiamo il corpo per comunicare, o anche la capacità di stabilire equilibrati legami affettivi.
“Il 12 per cento dei minori tra i 4 e i 10 anni utilizza già, o addirittura possiede, un dispositivo elettronico portatile e il 46 per cento dei bambini e ragazzi tra i 4 e i 17 anni lo utilizza senza alcun controllo genitoriale”. L’Italia ha poi un triste primato europeo, dal momento che registra il dato più alto per l’accesso allo smartphone senza la supervisione di un adulto. È quanto precisa Franco De Masi nel suo volume fresco di stampa No Smartphone. Come proteggere la mente dei bambini e degli adolescenti (Piemme, 2025).
Non stupisce allora la sempre più diffusa sindrome da disconnessione “nomofobia” (dall’inglese “no mobile phobia”), che genera ansia e panico (soprattutto in adolescenti e giovani, ma non solo in loro) quando non si ha con sé il cellulare o non si è in grado di farlo funzionare.
Da qui il recente appello (settembre 2024) di personaggi autorevoli, provenienti dal mondo della pedagogia, della psicologia e dello spettacolo, per chiedere di vietare per legge l’uso di smartphone ai minori di 14 anni e l’accesso ai social media prima dei 16.
Del resto, per Jonathan Haidt (La generazione ansiosa, Rizzoli 2024) l’utilizzo degli smartphone e dei social media ha prodotto negli adolescenti un progressivo aumento dei livelli di depressione, ansia, autolesionismo e anoressia, insieme con una diffusa avversione al rischio e un conseguente abbassamento dell’ambizione rispetto alle precedenti generazioni. Inoltre, le interazioni virtuali tendono a essere più superficiali di quelle reali, anche perché si avverte che la “reputazione è sempre in gioco” e, pur di restare nel gruppo, si vive in un’abituale modalità “difensiva” a scapito di una modalità “esplorativa” ben altrimenti proficua e funzionale. Ecco perché “anche una ragazza, che è consapevole del fatto che Instagram può favorire l’ossessione per la bellezza, l’ansia e i disturbi alimentari, potrebbe preferire correre questi rischi piuttosto che accettare l’apparente certezza di essere fuori dal giro, all’oscuro ed esclusa”.
Ritengo infine degno di qualche riflessione il risultato di un sondaggio inglese commissionato alla società Craft da Channel 4, i cui risultati sono stati pubblicati in prima pagina dal “Times” il 27 gennaio scorso. Il 52% degli intervistati – tutti tra i 13 e 27 anni, vale a dire i rappresentanti della ‘Generazione Z’ – si è dichiarato favorevole a un dittatore o a un autocrate: “oggi il Regno Unito sarebbe un posto migliore se ci fosse un leader forte al potere che non debba preoccuparsi di elezioni e Parlamento”. Il 58% degli intervistati considera però anche i messaggi ricevuti dagli amici sui social network altrettanto credibili, se non maggiormente credibili, delle informazioni pubblicate dai media tradizionali. Ed ecco un ulteriore attestato delle inquietanti radici di una crescente incapacità di distinguere tra vero e falso, tra la realtà e la sua falsificazione; ma ecco parimenti la conferma di come l’ambito dei social abbia dato vita a un mondo pieno di certezze, a una dimensione esistenziale che ha eliminato ogni forma di dubbio in favore di scelte decise e univoche in grado di assicurare soluzioni facili a dilemmi complessi.
Non si tratta però solo di un problema inglese. Da un sondaggio tutto italiano dell’aprile scorso, commissionato a Swg da Azione ("Ipotesi del premier con mani libere"), è emerso infatti che il 42% dei nostri giovani tra 18 e 24 anni e addirittura il 52% tra i 25 e 34 anni sarebbero favorevoli ad avere al governo "una persona autorevole, in grado di operare in autonomia, senza il controllo del Parlamento, e senza necessità di una maggioranza parlamentare, con un mandato fisso di cinque anni", vale a dire un autocrate a tempo definito. La percentuale degli over 64 favorevole al "premier con le mani libere" scende invece al 28%, a conferma che si tratta di un “fenomeno” esclusivo dei giovani, sul quale bisogna riflettere con urgenza.
Questi dati trovano poi significative conferme dalla nona edizione del sondaggio “Junges Europa 2025” del luglio scorso, condotto da YouGov per la Tui Stiftung tedesca. Solo il 57% dei giovani tra i 16 e i 26 anni di 6 Paesi della Comunità europea (Germania, Francia, Spagna, Italia, Grecia e Polonia) e del Regno Unito considera infatti la democrazia la migliore forma di governo; mentre il 21% degli intervistati si dichiara apertamente favorevole a una forma di governo “autoritaria, sotto alcune condizioni” (in realtà non precisate) e in Italia questa percentuale raggiunge il 24%, la più alta tra i Paesi esaminati.
Linee di tendenza ben documentate che confermano o addirittura vanno oltre i risultati delle indagini da me riportate nella relazione, ma che, nella loro costante ricerca di solide e semplici verità precostituite, continuano a porsi in aperto e crescente conflitto sia con le variegate pluralità di voci proprie dei contesti democratici, sia con una realtà sociale sempre più complessa e articolata.
Quali sono le connessioni che ha rilevato tra il tema della 'Fraternità', che il Festival affronta in questa nona edizione, e le varie modalità della realtà virtuale?
Internet, il web e i social media sono nati per connettere persone, oltre che per creare amicizia e fratellanza online. Ben presto però, soprattutto i social, hanno sortito l’effetto opposto, hanno cioè generato isolamento e solitudine. L’iperconnessione e l’abuso di dispositivi elettronici rendono infatti sempre più soli e diventano una fonte di dipendenza, mettendo a rischio la salute mentale in particolare di ragazzi e adolescenti. Tutto questo si è poi enormemente velocizzato e aggravato con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa. Prima di procedere oltre su questa riflessione, reputo tuttavia opportune alcune precisazioni preliminari e un po’ di storia. Quando parliamo della Rete, o meglio dell’insieme delle reti digitali, usiamo solitamente il termine Internet anche se il riferimento è più propriamente al World Wide Web (WWW o solo web). In realtà, Internet è l'hardware della Rete, l'infrastruttura dei cablaggi via cavo e wireless; vale a dire sia i cavi sottomarini, spesso in fibra ottica, che uniscono i continenti, sia le connessioni wireless come wifi, ponti radio e collegamenti satellitari che forniscono accesso locale e copertura sistematica. Il World Wide Web è invece il software della Rete, l’insieme di protocolli e applicazioni che fanno funzionare il tutto e che ci permettono di navigare e di usufruire di informazioni, video e altro; ecco perché se ci riferiamo a questo, cioè ai contenuti, dovremmo parlare più propriamente di “web”. Il primo dei social network, Facebook, nasceva nel 2004 per opera di 5 studenti dell’Università di Harvard, tra i quali spiccava Mark Zuckerberg, che poi, non senza controversie, ha perfezionato e commercializzato la piattaforma con enorme successo. Inizialmente solo gli studenti di Harvard potevano iscriversi, creare un proprio profilo con foto e condividere i propri interessi, connettendosi così con altri studenti e instaurando nuove amicizie. Poi la piattaforma si è aperta ad altre università (Stanford, Columbia, Yale) e infine al mondo intero; e qui hanno iniziato a manifestarsi problemi di spaesamento e di isolamento che caratterizzeranno ben presto anche gli altri social nati a getto continuo: 2005 YouTube, 2006 Twitter, 2009 WhatsApp, 2010 Instagram, 2010 Pinterest, 2016 TikTok. Nel 2009 la funzione ‘I like’ (già usata in applicazioni minori) è stata acquisita da Facebook ed è decollata subito in maniera esponenziale, rendendosi responsabile di ulteriori superficialità comunicative.
Può sembrare una contraddizione il fatto che iperconnessione e social network rendano più soli, ma è una realtà ben documentata e un crescente problema soprattutto per ragazzi, adolescenti e giovani. La “grande riconfigurazione” mentale e comunicativa, frutto dei cellulari di ultima generazione e dei social, genera infatti una “grande solitudine”.
Tutto l’opposto quindi, almeno in apparenza, delle tematiche di un Festival che ha come tema la “Fraternità”; in realtà una riflessione su queste enormi problematiche del nostro tempo può risultare di qualche interesse proprio in tale contesto, anche in considerazione del fatto che la “grande solitudine” è dovuta a realtà nate per generare nuovi legami amicali e fraterni.
La generazione attuale (la Gen. Z, che include le persone nate tra il 1997 e il 2012) si trova a vivere quella che viene indicata come “la più grande transizione antropologica dell’umanità” e che non si limita a un cambiamento di costumi, ma comporta una vera e propria modifica dello sviluppo cerebrale.
Sempre più spesso i nostri adolescenti non si piacciono fisicamente, sono ossessionati da un corpo idealizzato e si guardano con lo sguardo di altri, con conseguenze a volte drammatiche. Anche da questo (ma non solo da questo) deriva la fuga nella realtà virtuale dei social e il distacco dal mondo reale.
Aumentano in maniera preoccupante i giovani italiani in totale isolamento sociale (fonti autorevoli parlano di circa 70.000); si tratta di ragazzi e adolescenti afflitti da una condizione di “ritiro sociale” che comporta un volontario abbandonano delle relazioni amicali, della scuola e di tutti i contatti sociali, per rinchiudersi in camera e isolarsi persino dalla famiglia, dedicandosi esclusivamente a giochi e connessioni virtuali online.
Un crescente allarme Hikikomori nel nostro Paese (dal fenomeno giapponese registrato già negli anni ’80) è stato nuovamente ribadito proprio nei giorni scorsi da associazioni specialistiche (prima fra tutte Hikikomori Italia), che non esitano a indicare come causa prevalente la paura di fallire, tanto marcata da diventare paralizzante, in un contesto deteriorato da forme di bullismo soprattutto sui social e alte aspettative da parte degli adulti.
Luciano Floridi ci ricorda ormai da tempo che viviamo sempre più in una realtà “onlife” nella quale convivono e si intersecano, aldilà delle nostre intenzioni, la dimensione online con quella dell’esistenza reale, in un intreccio che molto spesso ci sfugge in tutto il suo spessore e nelle sue conseguenze. Ma queste patologie giovanili vanno ben oltre, dal momento che in esse la dimensione virtuale diventa sempre più totalizzante; proprio per questo necessitano di maggiore consapevolezza e di interventi non ulteriormente dilazionabili.
Intervista a cura di Tiziana Bartolini

Scarica il PDF
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®








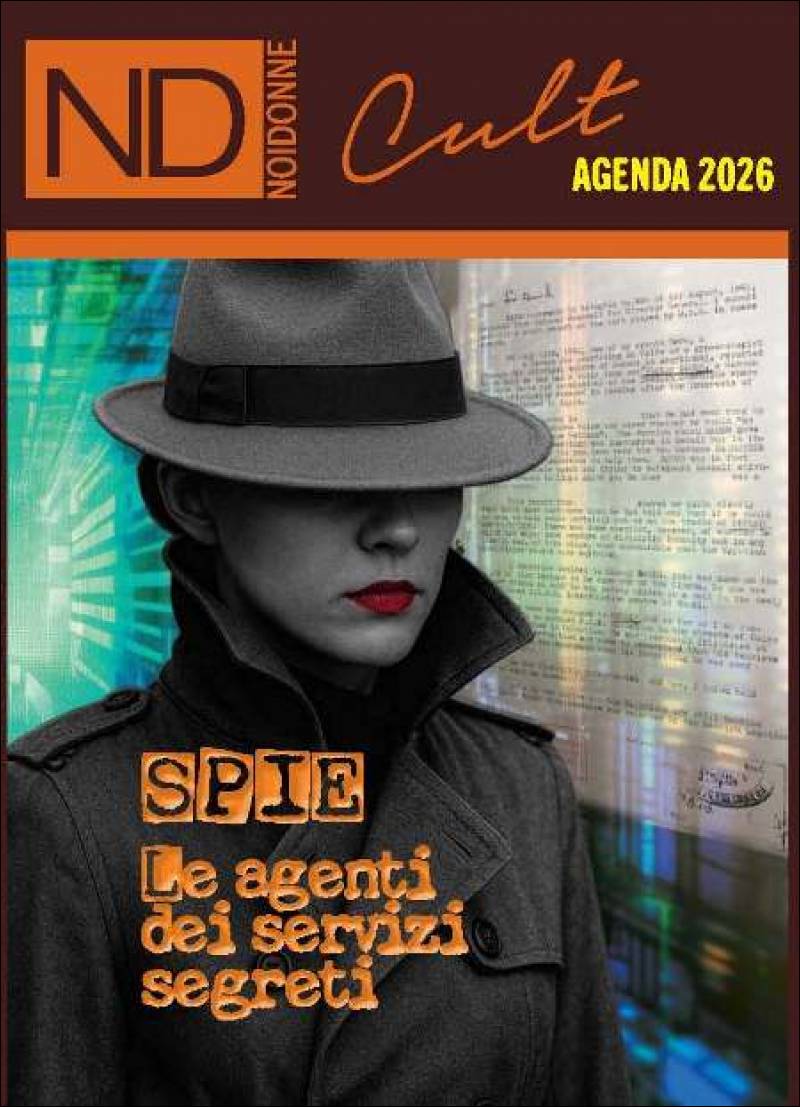
Lascia un Commento