
Libere, non coraggiose
Il testo "Libere, non coraggiose" di Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro ci aiuta a ragionare su questi temi e a superare la paura degli spazi pubblici, a progettare città più sicure.
Martedi, 11/11/2025 - Sex & the City è un'associazione fondata nel 2022 da Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro, che osserva le città da un punto di vista di genere, cercando di fornire alle amministrazioni pubbliche uno strumento utile a formulare politiche che possano organizzare gli spazi puntando al benessere collettivo.
Il testo "Libere, non coraggiose" di Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro ci aiuta a ragionare su questi temi e a superare la paura degli spazi pubblici, a progettare città più sicure.
Di “fronte alla paura, lo spazio pubblico viene percepito come minaccioso, il che può portare a situazioni estreme di abbandono dello spazio pubblico con il conseguente impoverimento individuale e sociale. Si perde così il senso dello spazio pubblico come spazio di interazione sociale, il luogo in cui si costruisce il senso di appartenenza collettiva, l’esercizio stesso del diritto di cittadinanza. Solo conquistando le strade, le piazze ed essendo questi spazi destinati alla diversità, guadagneremo in sicurezza” (Ana Falù 2012).
Il senso di appartenenza a un territorio e la cura collettiva forniscono una base importante alla creazione di comunità di mutuo supporto, ma è necessario anche mettere al centro ciò che riguarda la libertà delle donne dal pericolo di essere aggredite sessualmente (anche se sappiamo che la maggior parte delle violenze avviene in ambiente domestico).
“Una buona illuminazione, buoni trasporti, un’adeguata assistenza all’infanzia, un’istruzione decente, case sicure e relazioni sicure: uno senza gli altri è inadeguato a rispondere ai bisogni delle donne e, di conseguenza, alla loro paura del crimine” (Stanko 1995).
“Sebbene non sia possibile risolvere la paura mediante la legislazione e la pianificazione, è in ogni caso etico e sensato impegnarsi e ascoltare le persone che esprimono paura nei confronti della violenza nello spazio pubblico, poiché queste percezioni hanno effetti reali sulla vita e sul benessere delle persone” (Carolyn Whitzman 2008).
Abbiamo voluto dialogare con le autrici, per approfondire strumenti e modalità attuabili nella realtà cittadina.
Da dove nasce la necessità di scrivere e indagare la città in ottica di genere?
Dalla constatazione che le città sono state storicamente progettate da uomini e per uomini, trascurando le esperienze e i bisogni di chi vive la città in modi diversi: donne, persone anziane, bambine e bambini, persone con disabilità o con ruoli di cura. Applicare una prospettiva di genere all’urbanistica significa mettere al centro la vita quotidiana e interrogare come le forme dello spazio pubblico rispondono (o non rispondono) a tali necessità.
Quali sono i focus principali su cui vi siete soffermate?
Nel nostro lavoro ci siamo concentrate su mobilità, sicurezza, accessibilità e cura. In particolare, abbiamo analizzato la paura nello spazio pubblico e il modo in cui essa limita la libertà di movimento delle donne, come raccontiamo in Libere, non coraggiose.
La progettazione urbana di quali elementi dovrebbe tener conto?
Oltre alle dimensioni fisiche, è fondamentale considerare quelle sociali e relazionali. L’urbanistica può favorire o ostacolare la possibilità di incontrarsi, di muoversi in autonomia, di sentirsi parte di una comunità. Gli spazi devono quindi essere pensati in funzione della vita quotidiana e dei tempi reali delle persone.
Un’urbanistica di genere può far sentire le donne più al sicuro?
Sì, ma non solo attraverso interventi di tipo securitario (forze dell'ordine, videosorveglianza, ecc.). Si tratta di rendere gli spazi più vitali, attraversabili, plurali nelle funzioni e nei tempi d’uso. La sicurezza non è solo una questione di controllo, ma di presenza e di cura dello spazio.
Esempi di progettazione in quest’ottica?
A Vienna, sin dagli anni Novanta, più di sessanta progetti pilota sullo spazio pubblico hanno integrato le esigenze della vita quotidiana nella progettazione urbana. A Barcellona, il collettivo Punt 6 ha elaborato strumenti di analisi e progettazione partecipata che ispirano molti nostri progetti.
L’università e la formazione come si stanno muovendo?
Il tema sta lentamente entrando nei corsi di laurea e nei master, ma resta ancora marginale. Manca una formazione sistematica sull’urbanistica di genere, mentre cresce l’interesse da parte delle nuove generazioni di professioniste e professionisti.
Le gare d’appalto e le valutazioni di genere nei progetti pubblici?
Si potrebbero introdurre criteri premiali legati all’impatto di genere, come già avviene in alcuni programmi europei. Ogni progetto urbano dovrebbe essere valutato anche in base alla sua capacità di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la qualità della vita per tuttə.
A che punto è Milano, per esempio?
Milano ha mostrato attenzione al tema, anche grazie a studi come il Milano Atlante di Genere che abbiamo sviluppato per l’Urban Center. Tuttavia, resta molto da fare: il cambiamento richiede un approccio strutturale, non solo sperimentale.
Le periferie e la mobilità?
Nei quartieri più lontani dal centro pesano la carenza di servizi di prossimità e la scarsa qualità dei collegamenti pubblici. Le donne, che spesso si muovono in modo intermodale e con tragitti complessi, sono tra le più penalizzate. Servono trasporti più capillari, sicuri e flessibili, e una distribuzione più equa delle funzioni urbane.
Esempi virtuosi?
Oltre a Vienna e Barcellona, anche Umea, Parigi e alcune città canadesi hanno adottato piani urbani con una prospettiva di genere. In Italia il tema è in crescita, ma serve un salto di scala istituzionale.
Il testo "Libere, non coraggiose" di Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro ci aiuta a ragionare su questi temi e a superare la paura degli spazi pubblici, a progettare città più sicure.
Di “fronte alla paura, lo spazio pubblico viene percepito come minaccioso, il che può portare a situazioni estreme di abbandono dello spazio pubblico con il conseguente impoverimento individuale e sociale. Si perde così il senso dello spazio pubblico come spazio di interazione sociale, il luogo in cui si costruisce il senso di appartenenza collettiva, l’esercizio stesso del diritto di cittadinanza. Solo conquistando le strade, le piazze ed essendo questi spazi destinati alla diversità, guadagneremo in sicurezza” (Ana Falù 2012).
Il senso di appartenenza a un territorio e la cura collettiva forniscono una base importante alla creazione di comunità di mutuo supporto, ma è necessario anche mettere al centro ciò che riguarda la libertà delle donne dal pericolo di essere aggredite sessualmente (anche se sappiamo che la maggior parte delle violenze avviene in ambiente domestico).
“Una buona illuminazione, buoni trasporti, un’adeguata assistenza all’infanzia, un’istruzione decente, case sicure e relazioni sicure: uno senza gli altri è inadeguato a rispondere ai bisogni delle donne e, di conseguenza, alla loro paura del crimine” (Stanko 1995).
“Sebbene non sia possibile risolvere la paura mediante la legislazione e la pianificazione, è in ogni caso etico e sensato impegnarsi e ascoltare le persone che esprimono paura nei confronti della violenza nello spazio pubblico, poiché queste percezioni hanno effetti reali sulla vita e sul benessere delle persone” (Carolyn Whitzman 2008).
Abbiamo voluto dialogare con le autrici, per approfondire strumenti e modalità attuabili nella realtà cittadina.
Da dove nasce la necessità di scrivere e indagare la città in ottica di genere?
Dalla constatazione che le città sono state storicamente progettate da uomini e per uomini, trascurando le esperienze e i bisogni di chi vive la città in modi diversi: donne, persone anziane, bambine e bambini, persone con disabilità o con ruoli di cura. Applicare una prospettiva di genere all’urbanistica significa mettere al centro la vita quotidiana e interrogare come le forme dello spazio pubblico rispondono (o non rispondono) a tali necessità.
Quali sono i focus principali su cui vi siete soffermate?
Nel nostro lavoro ci siamo concentrate su mobilità, sicurezza, accessibilità e cura. In particolare, abbiamo analizzato la paura nello spazio pubblico e il modo in cui essa limita la libertà di movimento delle donne, come raccontiamo in Libere, non coraggiose.
La progettazione urbana di quali elementi dovrebbe tener conto?
Oltre alle dimensioni fisiche, è fondamentale considerare quelle sociali e relazionali. L’urbanistica può favorire o ostacolare la possibilità di incontrarsi, di muoversi in autonomia, di sentirsi parte di una comunità. Gli spazi devono quindi essere pensati in funzione della vita quotidiana e dei tempi reali delle persone.
Un’urbanistica di genere può far sentire le donne più al sicuro?
Sì, ma non solo attraverso interventi di tipo securitario (forze dell'ordine, videosorveglianza, ecc.). Si tratta di rendere gli spazi più vitali, attraversabili, plurali nelle funzioni e nei tempi d’uso. La sicurezza non è solo una questione di controllo, ma di presenza e di cura dello spazio.
Esempi di progettazione in quest’ottica?
A Vienna, sin dagli anni Novanta, più di sessanta progetti pilota sullo spazio pubblico hanno integrato le esigenze della vita quotidiana nella progettazione urbana. A Barcellona, il collettivo Punt 6 ha elaborato strumenti di analisi e progettazione partecipata che ispirano molti nostri progetti.
L’università e la formazione come si stanno muovendo?
Il tema sta lentamente entrando nei corsi di laurea e nei master, ma resta ancora marginale. Manca una formazione sistematica sull’urbanistica di genere, mentre cresce l’interesse da parte delle nuove generazioni di professioniste e professionisti.
Le gare d’appalto e le valutazioni di genere nei progetti pubblici?
Si potrebbero introdurre criteri premiali legati all’impatto di genere, come già avviene in alcuni programmi europei. Ogni progetto urbano dovrebbe essere valutato anche in base alla sua capacità di migliorare l’accessibilità, la sicurezza e la qualità della vita per tuttə.
A che punto è Milano, per esempio?
Milano ha mostrato attenzione al tema, anche grazie a studi come il Milano Atlante di Genere che abbiamo sviluppato per l’Urban Center. Tuttavia, resta molto da fare: il cambiamento richiede un approccio strutturale, non solo sperimentale.
Le periferie e la mobilità?
Nei quartieri più lontani dal centro pesano la carenza di servizi di prossimità e la scarsa qualità dei collegamenti pubblici. Le donne, che spesso si muovono in modo intermodale e con tragitti complessi, sono tra le più penalizzate. Servono trasporti più capillari, sicuri e flessibili, e una distribuzione più equa delle funzioni urbane.
Esempi virtuosi?
Oltre a Vienna e Barcellona, anche Umea, Parigi e alcune città canadesi hanno adottato piani urbani con una prospettiva di genere. In Italia il tema è in crescita, ma serve un salto di scala istituzionale.
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®


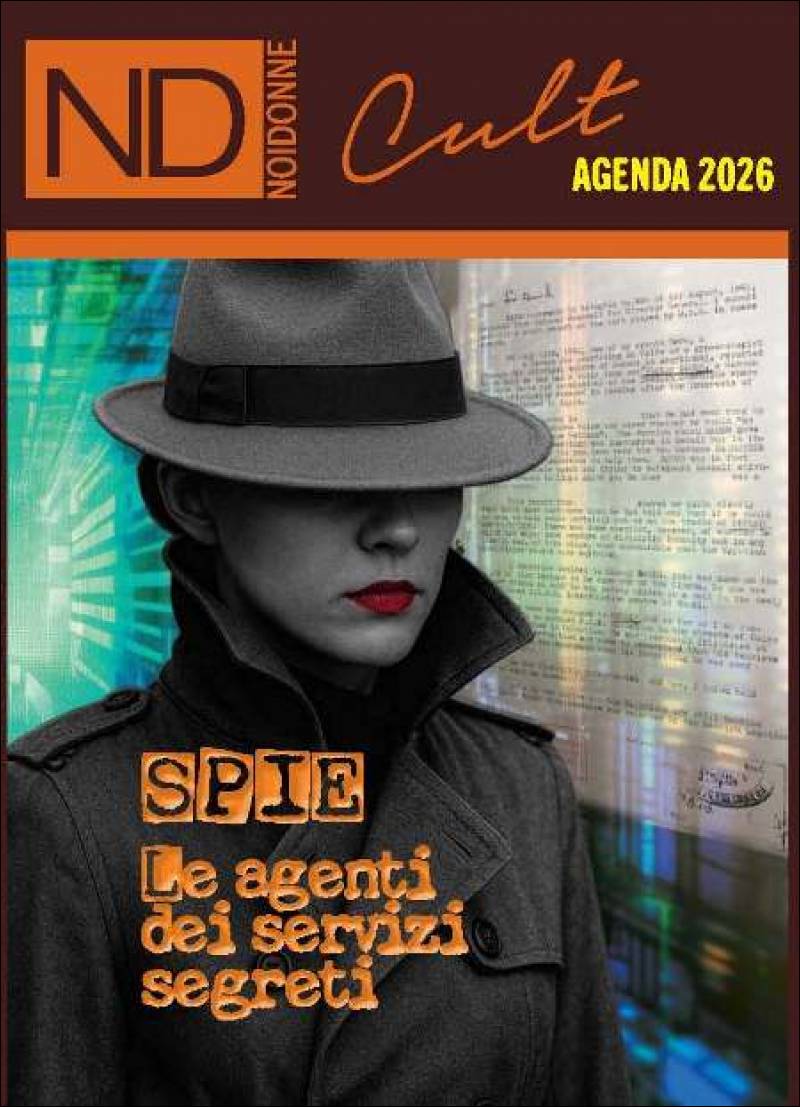

Lascia un Commento