
Mauro Ceruti: ‘La fraternità come appartenenza ad un’unica comunità universale'
Un’anticipazione della Lectio magistralis del filosofo al Festival di Bioetica 2025 sulla complessità della condizione umana globale
 Lunedi, 18/08/2025 -
Lunedi, 18/08/2025 -
Filosofo e teorico del pensiero complesso, Mauro Ceruti ha lavorato molto anche sul tema dell'umanizzazione delle relazioni. Nel saggio "Il secolo della fraternità" (Castelvecchi, 2021) parla del "tempo della complessità" come "tempo della fraternità" per sostenere la sfida che la modernità ci pone con il rapido aumento della tecnologia che riguarda tutti gli umani. Durante il Festival di Bioetica gli sarà consegnato il Premio Bioetica 2025 e in tale occasione terrà una Lectio magistralis sul tema della 'Fraternità', focus della nona edizione del Festival organizzato dall'Istituto Italiano di Bioetica che si tiene a Rapallo il 29 e 30 agosto.
A noi, comuni cittadini, le parole 'Fraternità' e complessità evocano panorami di significati molto diversi e difficilmente coniugabili. Può suggerire qualche elemento di riflessione per aiutarci a cogliere le relazioni che lei rileva?
Abitare la complessità richiede la capacità di indossare “occhiali diversi”. Ed è sul terreno cruciale dell’educazione che si giocherà la partita per realizzare il cambiamento di paradigma che il nuovo tempo esige. È la sfida di una nuova Paideia.
Dobbiamo innanzitutto prendere consapevolezza di una profonda crisi cognitiva. Questa crisi concerne la difficoltà di pensare la complessità del nostro mondo e del nostro tempo, in cui tutto è connesso. Infatti, viviamo un paradosso. Lo rivelano drammaticamente le crisi globali che stiamo vivendo. Più aumenta la complessità del nostro mondo, più aumenta la tentazione della semplificazione. Più la complessità si impone come sfida ineludibile alla nostra esperienza e alla nostra conoscenza, più essa tende a essere negata e rimossa.
La tendenza alla semplificazione ha radici storiche e culturali profonde nella nostra tradizione culturale. Questa tradizione ha cercato di conoscere le cose nella loro separazione: innanzitutto la separazione fra ciò che è umano e ciò che è naturale, tra noi e le cose che conosciamo, tra il soggetto e l’oggetto; poi la separazione delle cose dal loro contesto e la scomposizione delle cose in tante parti elementari, “semplici”; e infine la separazione del sapere stesso in tante discipline, sempre più chiuse ciascuna in se stessa e fra loro lontane.
Così, l’ostacolo alla formulazione stessa dei problemi complessi del nostro tempo si annida proprio nel modo in cui la conoscenza è prodotta, organizzata e trasmessa. Continuano a essere separate conoscenze che dovrebbero essere interconnesse, perché interconnessi e non separabili sono i molteplici aspetti dei problemi da formulare e da affrontare. Si isolano singoli aspetti di un problema complesso, e si conferma l’illusione di poterli affrontare separatamente con semplici soluzioni tecniche. Le soluzioni cercate e proposte sono dunque il più delle volte, esse stesse, parte e causa del problema. I modi di pensare che utilizziamo per trovare soluzioni alle crisi, come ai problemi più gravi della nostra età globale, costituiscono, essi stessi, uno dei problemi più gravi che dobbiamo affrontare. Perché sono modi di pensare che frazionano ciò che nella realtà è intimamente connesso.
Tracciare confini, fissare la propria identità nell’opposizione all’alterità, così come cercare una soluzione univoca, semplice, astratta, quantificabile, sono atteggiamenti che hanno intessuto un abito mentale talmente radicato da far apparire persino implausibile un altro modo di pensare, come quello complesso. Perciò, una nuova Paideia deve volgersi a rigenerare il pensiero, laddove il progresso delle conoscenze nei binari della parcellizzazione suscita una regressione del pensiero stesso, che rischia di fossilizzarsi nell’esercizio “automatico” delle mansioni o delle tecniche di gestione. Ed ecco perché è ancora più preoccupante che da questa regressione e semplificazione del pensiero oggi possano essere investite proprio la scuola, e proprio la pedagogia. La complessità della condizione umana globale ci sfida a generare una Paideia che contenga in sé il senso dell’irriducibile legame di ogni cosa con ogni cosa.
Nel suo libro osserva che la "fraternità rimane la promessa mancata della modernità, che però potrà essere la protagonista nel XXI secolo, dopo che la libertà e l’uguaglianza lo sono state nei secoli XIX e XX". Purtroppo il mondo sembra andare nella direzione opposta, con preoccupanti spirali di egoismi e violenze senza fine. Ci piacerebbe guardare il futuro con ottimismo, ma risulta difficile. Lei che ne pensa?
Un nuovo umanesimo planetario, che rigeneri l’umanesimo classico, può esprimere un universalismo reso concreto appunto dal destino comune che lega ormai fra loro tutti gli esseri umani, tutti i popoli del pianeta, e che lega l’umanità intera all’ecosistema globale, alla Terra e a tutte le diversità viventi e non viventi. Questo universalismo concreto non oppone la diversità all’unità. Si basa sul riconoscimento dell’unità nelle diversità umane e sul riconoscimento del valore delle diversità nell’unità umana.
La fraternità si fonda sul sentimento di una mutua appartenenza e si vive nella coscienza di appartenere a una stessa comunità e di agire in questo senso. Ma la fraternità può essere, e lo è stata e continua a esserlo, una fraternità chiusa, che fa sentire fratelli contro qualcuno, “altro”, diverso. I nazionalismi hanno fomentato questa fraternità che separa. E sono risorti nel nostro tempo, dopo che parevano indeboliti in seguito alle catastrofi che avevano prodotto con le guerre mondiali.
Smarrimento, incertezza, solitudine oggi inducono illusoriamente a cercare ancora nicchie protettive, nemici, capri espiatori. Generano chiusura, semplificazione identitaria.
L’unificazione tecnoeconomica del mondo non ha portato alla fine della Storia, non ha condotto al trionfo ultimo della modernità e delle sue promesse. Ha portato alla sua crisi, alla sua “policrisi”, che minaccia di tramutarsi in una “policatastrofe” dell’umanità. Un’umanità che, come dice Edgar Morin, continua ad avvitarsi in una duplice impasse: “l’impotenza del mondo a diventare mondo e l’impotenza dell’umanità a diventare umanità”.
La storia ci trascina oggi in una drammatica biforcazione: siamo sull’orlo di un oscuro precipizio. Ma, nello stesso movimento, siamo sulla soglia di un possibile strepitoso salto nel processo di umanizzazione. Non sappiamo se l’agonia nella quale siamo entrati sia l’agonia della nascita o l’agonia della morte dell’umanità.
Da parte mia, continuo a ricercare le ragioni di una speranza dentro l’involucro spesso e vorticoso dell’improbabilità e dell’incertezza. La speranza che, nonostante tutto, si stia formando e riformando una coscienza planetaria, una coscienza dell’umanità, diventata, di fatto, una concreta comunità di destino.
Oggi, per la prima volta nella storia dell’umanità, la fraternità si definisce in un orizzonte “concretamente universale”. Nessuno si può salvare da solo. Il progetto moderno di dominio della Terra e di emancipazione dalla Terra, per una eterogenesi dei fini, ci ha fatto tutti insieme riatterrare… Siamo sulla stessa barca, la Terra.
Intervista a cura di Tiziana Bartolini
.jpg)
Scarica il PDF
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®







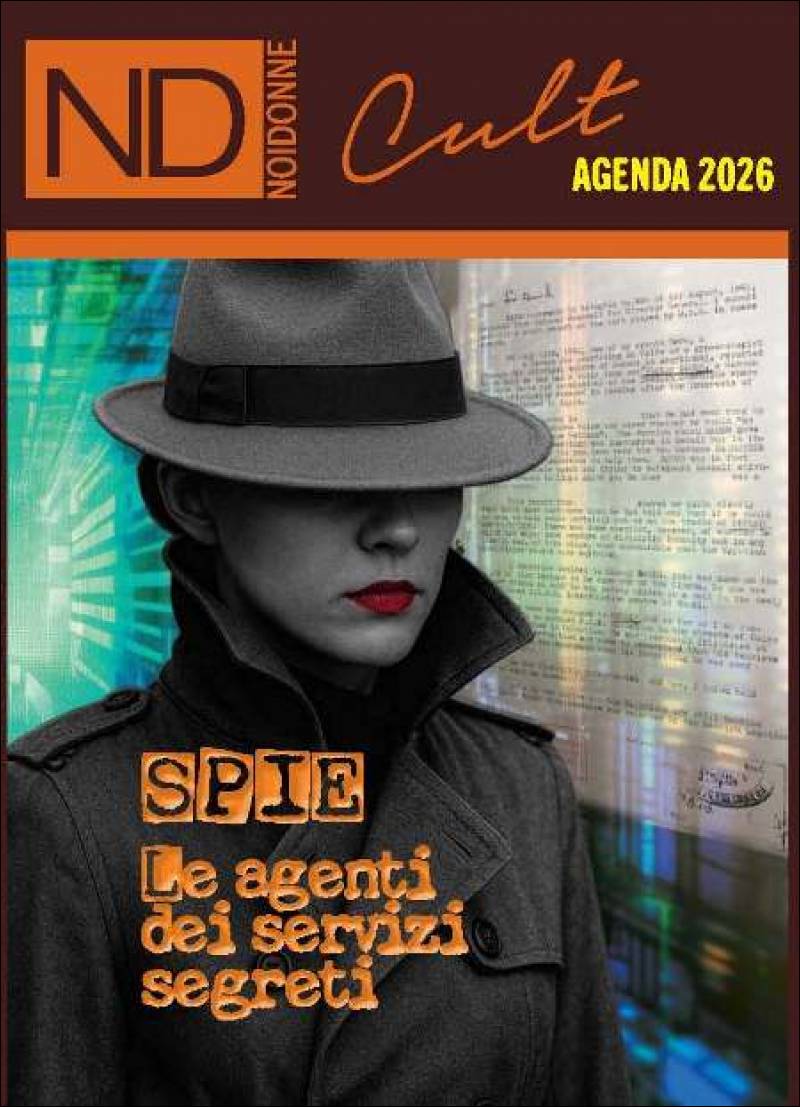
Lascia un Commento