
Con le donne ieri, oggi e domani: il “Diario degli anni difficili” di Dacia Maraini
A partire dal suo ultimo libro, una conversazione con Alma Daddario spazia dal patriarcato all'amicizia con Piera Degli Esposti fino all'intelligenza artificiale
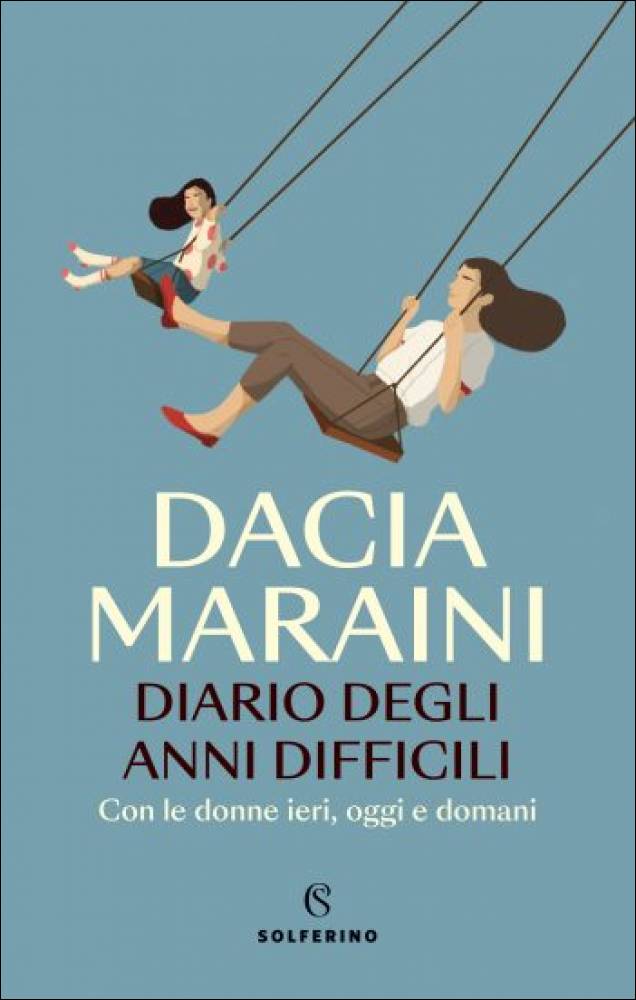 Domenica, 27/04/2025 - “Non si tratta di un saggio, bensì di considerazioni che partono da fatti concreti e reali, con la presentazione di personaggi osservati nella difficile pratica di stare al mondo” Dacia Maraini
Domenica, 27/04/2025 - “Non si tratta di un saggio, bensì di considerazioni che partono da fatti concreti e reali, con la presentazione di personaggi osservati nella difficile pratica di stare al mondo” Dacia MarainiAutrice di romanzi, racconti, opere teatrali, saggi, soggetti cinematografici, Dacia Maraini è una delle nostre scrittrici più tradotte al mondo. Tra i premi vinti: il Campiello, lo Strega, Brancati Zafferana. Tra i romanzi più noti: “L’età del malessere”, “Donne in guerra”, “Buio”, “La lunga vita di Marianna Ucrìa”, “Teresa la ladra”, “Bagheria”. Da alcuni di questi sono stati tratti dei film e anche adattamenti teatrali. Tra gli ultimi libri pubblicati: “Sguardo a oriente” , “Vita mia” e “Diario degli anni difficili”. Le sue opere, da sempre, sono caratterizzate da una particolare attenzione alle questioni femminili nella società e nel privato, nei vari contesti storici e culturali. L’abbiamo incontrata in occasione della presentazione de “Il diario degli anni difficili”, edito da Solferino, che è una testimonianza pratica delle tante difficoltà che ancora impediscono alle donne di ogni età, cultura, provenienza, di far valere diritti e libertà di scelte, nelle riflessioni dell’autrice e nei fatti di cronaca narrati. Si parla anche di violenza, quella raccontata nelle cronache odierne, quella fisica, ma anche quella psicologica, meno evidente perché più subdola e difficile da denunciare.
Rispetto al periodo in cui hai iniziato a scrivere, negli anni Sessanta, questi nostri anni sono più difficili da vivere?
Ogni periodo ha dolori e gioie, successi e sconfitte. In quegli anni non c’erano i pericoli dell’autoritarismo che sentiamo oggi, non si vedeva un attacco alle democrazie, come sta succedendo oggi in tutto il mondo, non solo dal punto di vista economico e militare ma anche ideologico ed esistenziale, cosa che mi preoccupa molto. C’erano altre preoccupazioni: la povertà, un paese da ricostruire, la mafia che stabiliva rapporti con lo Stato, il moralismo tradizionale da combattere, i diritti delle donne da conquistare, la crisi della famiglia contadina, ecc. Tutti temi che avevo iniziato ad affrontare già a 13 anni, cominciando a scrivere per il giornale della scuola, pochi anni dopo la guerra.
Hai conosciuto e vissuto a fianco di grandi intellettuali come Pasolini, Moravia, e altri. A quel tempo eri giovanissima, ne sei stata condizionata?
Io sono stata condizionata prima di tutto da un padre antropologo, Fosco Maraini, che mi ha contagiato con l’amore per la storia, da una madre intelligente e coraggiosa, Topazia Alliata, che mi ha insegnato l’amore per la scienza e l’arte. Poi certo sono arrivati anche gli amici intellettuali, ma avevo già letto tanto e scritto tanto da me. Loro hanno semmai rinforzato nell’idea della autonomia intellettuale, del rigore critico, della partecipazione pratica come cittadini oltre che intellettuali,alla storia civile del paese.
In questi giorni si è riaperto il dibattito sul femminicidio, in realtà mai interrotto. La cultura patriarcale ha le sue colpe, ma molte voci si levano contro le madri degli “assassini”, che hanno una grande responsabilità, soprattutto quando difendono o cercano di giustificare il comportamento dei figli maschi violenti. Cosa ne pensi?
È facile dare la colpa alle madri, sono spesso anche loro vittime del patriarcato, così come i padri, inconsapevoli e perciò ciechi. Veniamo da quasi tremila anni di santificazione della figura della madre che dona tutta se stessa ai figli, anche annientandosi. Quelle che si comportano con indulgenza eccessiva nei riguardi dei figli maschi sono succubi di una cultura che le esalta solo se sacrificano ogni autonomia morale e di pensiero alla maternità. Il femminicidio all’interno di una coppia, per esempio, deriva soprattutto dalla paura di alcuni uomini di perdere potere sulla donna che considerano propria. Troppo comodo avere una persona che lavora gratuitamente in casa, si occupa dei figli, fa l’amore anche quando non ne ha voglia e si preoccupa di tenere in piedi la famiglia dal punto di vista affettivo ed etico secondo i dettami sociali. Naturalmente non riguarda tutti gli uomini. Un uomo equilibrato accetta di perdere qualche privilegio nell’ambito di un rapporto o nella famiglia, è in grado di adeguarsi ai tempi. I più deboli, le indoli più fragili, condizionati da una cultura patriarcale che sino a oggi li ha fatti sentire forti e protetti, sono spaventati dall’autonomia della donna che considerano una loro proprietà, e qualunque tipo di richiesta o rifiuto li mette in una crisi tale che preferiscono addirittura uccidere, piuttosto che accettare l’affronto alla propria idea di virilità, che nei secoli ha assicurato loro i privilegi non consentiti alle donne.
Nel corso dei secoli in campo artistico, le donne sono state relegate al ruolo di “muse” per tanti pittori, scrittori, musicisti, e quando manifestavano il desiderio, accompagnato da evidenti capacità, di prendere loro in mano il pennello, la penna, o qualsiasi altra cosa che le rendesse anche soggetti e non solo oggetti, venivano messe in ombra e nei casi più drammatici trattate come pazze, nevrotiche, frustrate. Tanti gli esempi: Elisabeth Siddal, moglie di Dante Gabriele Rossetti, Leonor Carrington, compagna di Max Ernst, Camille Claudel, allieva e compagna di Auguste Rodin su cui hai scritto anche uno splendido testo teatrale. Come se fosse assodato che una donna non potesse raggiungere certi livelli di genio e capacità creative. Tu stessa sei stata vittima di pregiudizi di questo genere, quando sei diventata ufficialmente la compagna di Alberto Moravia...
Per il patriarcato le donne erano da venerare e amare ma come amanti oppure come madri. Non si credeva nella loro intelligenza creativa e nelle loro capacità artistiche. La creatività era una prerogativa maschile, così come la capacità di gestire la conoscenza, e attraverso questa il potere sociale ed economico. Così come le donne erano ritenute meno coraggiose, incapaci di difendere e difendersi di combattere per se stesse o per un ideale. Questo è accaduto anche nella storia recente, per quello che riguarda le nostre partigiane, che in guerra non hanno avuto solo il ruolo di staffette come credono molti. Questa l’idea fondante e molto radicata del patriarcato, e in tutti i tipi di regimi. Il recente accesso delle donne alle professioni, le rivendicazioni di autonomia e libertà di scelta nel pubblico e nel privato, hanno messo in crisi la famiglia tradizionale e tutte le leggi che la tutelavano. Questo ha comportato disorientamento in molti uomini e nelle istituzioni patriarcali, fomentando quei femminicidi che non avvengono solo per egoismo o gelosia, ma per una paura profonda che tocca il senso di identità. Ma quando il senso di identità è fortemente condizionato dall’arretratezza di secoli di cultura dominante, è difficile da gestire.
Dai tuoi romanzi sono anche stati tratti dei film. Cinema e letteratura si sa sono linguaggi diversi. C’è un regista con cui ti sei trovata in perfetta sintonia, o uno che ti ha fatto anche arrabbiare?
Di solito mi sono trovata bene coi registi che hanno trasformato in film i miei romanzi: Marco Ferreri, Roberto Faenza, Margarethe Von Trotta, Salvatore Samperi, Sofia Scandurra. Io non pretendo di partecipare alla sceneggiatura di un film se non me lo chiedono, mi affido e lascio molta libertà di interpretazione al regista, perché so quanto sia diverso il linguaggio cinematografico e quanti problemi abbia nel raccontare per immagini una storia fatta di parole.
In “Diario degli anni difficili”, il tuo ultimo libro edito da Solferino, nel capitolo dedicato a Frida Khalo c’è la descrizione di un suo quadro che ho trovato molto significativa: “Forse la tela più struggente è quella che mostra una cerva con la faccia di donna che corre in un bosco. Il corpo è trafitto da frecce come un San Sebastiano ferito, ma non soggiogato….sono quadri che parlano di un corpo femminile che patisce ma si agghinda a festa per resistere alle sofferenze. Un corpo che capovolge la sconfitta in trionfo. Nessuno come Frida Khalo ha saputo raccontare il dolore che non chiede pietà, non chiede compassione, ma amore, riconoscimento, fiducia”.
Infatti,credo che il grande successo di Frida Khalo venga dal modo in cui lei racconta il dolore e lo strazio. Non c’è mai recriminazione né resa nei suoi quadri che, attraverso la presenza di fiori, scimmie, uccelli colorati, trasforma il dolore in gioia di vivere.
Tra le tue grandi amicizie, oltre a Pierpaolo Pasolini, c’e stata la grande attrice Piera degli Esposti, con cui hai scritto un libro e realizzato la sceneggiatura per un film diretto da Marco Ferreri: “Storia di Piera”, com’era il vostro rapporto?
Piera era una donna vitale, piena di risorse. Ci ha fatte conoscere Pier Paolo Pasolini, che mi aveva proposto di scrivere una Medea teatrale con lei come protagonista. Così abbiamo cominciato a vederci per lavorare su questo progetto. Ma più che parlare di Medea, Piera mi raccontava di sua madre e della sua infanzia, e questo alla fine è diventato il centro della storia. Il rapporto tra madre e figlia che lei aveva vissuto era da una parte terribile, dall’altra straordinario. La madre di Piera in inverno andava in letargo come un’orsa, per poi svegliarsi in primavera e prendere a girare in bicicletta cercando qualcuno con cui fare l’amore. A un certo punto l’hanno presa per pazza e hanno cominciato a farle degli elettrochoc. Piera andava mano nella mano con sua madre accompagnandola a quelle torture mediche in ospedale, per farle coraggio, anche se era piccola, e me lo raccontava come se fosse stata la cosa più normale al mondo. Comunque, malgrado fosse solo una bambina, non aveva mai provato rancore o spirito vendicativo verso quella madre un po' strana che tutti additavano come pazza e che adorava. Alla fine, invece di un testo teatrale ne abbiamo scritto un libro. Marco Ferreri l’ha letto e ha deciso di farne un film. Abbiamo lavorato insieme per mesi sulla sceneggiatura, e da lì è nata la nostra amicizia. D’estate Piera veniva nella mia casa di Pescasseroli per un mese almeno, e facevamo delle belle passeggiate in tre, con Giuseppe, il mio compagno di allora, scomparso prematuramente. Mi manca tanto la sua allegria, il suo umorismo, la sua voce squillante sempre pronta a raccontare storie. È stata davvero un’amica importante.
Per finire una domanda che molti in questo periodo si aspettano: cosa ne pensi dell’intelligenza artificiale, e dell’utilizzo – negativo o positivo – che se ne potrebbe fare per scrivere libri, sceneggiature, saggi?
L’intelligenza artificiale c’è e non si può tornare indietro. La si può usare con buon senso. Come tutte le grandi invenzioni, va trattata con prudenza e attenzione perché può rivelarsi pericolosa. Come l’energia atomica per esempio, che può rappresentare una buona risorsa, ma anche portare morte e distruzione se trasformata in una bomba. Sono comunque del parere che la creatività umana, di chi inventa e scrive storie per esempio, non possa essere rimpiazzata da una sorta di congegno privo di propria autonomia, che utilizza e ripropone dati comunque generati e codificati da una mente umana, privo di una vera autonomia e libertà di scelta. Gli esseri umani sono molto creativi anche sul piano tecnologico certo, ma guai a diventare dipendenti delle nostre stesse creazioni.
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®





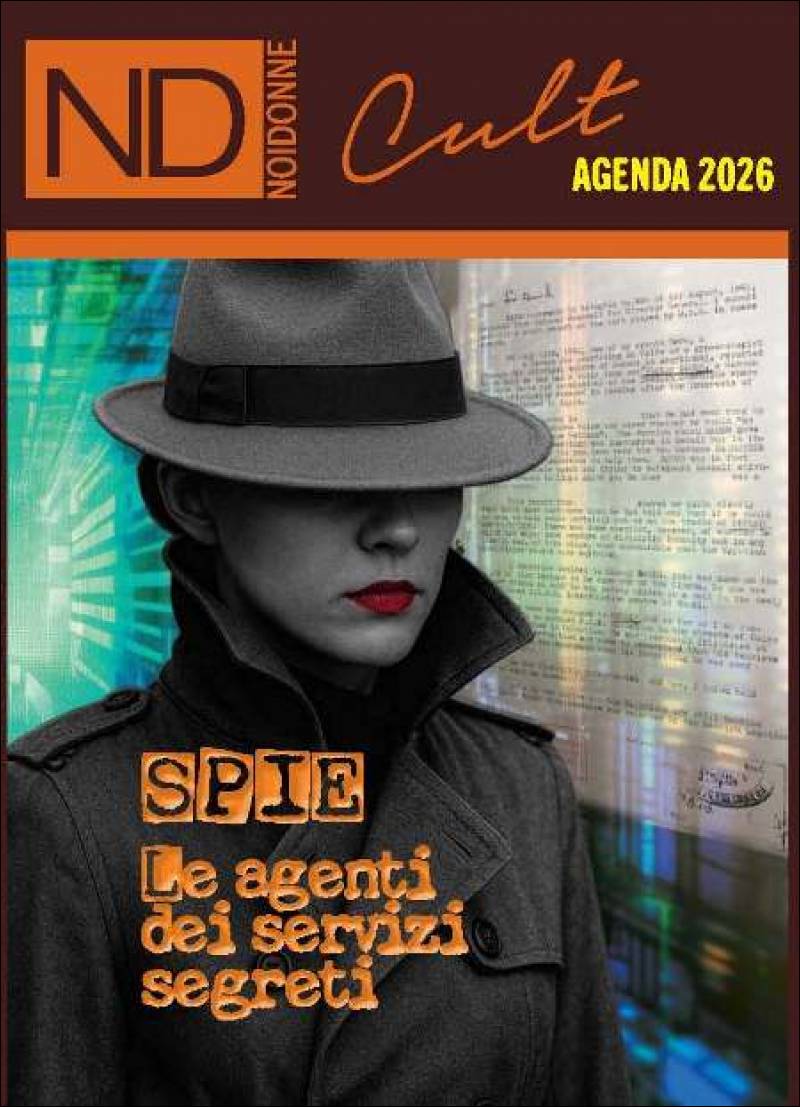
Lascia un Commento