
La guerra in Ucraina vista dalle donne. Intervista a Marina Sorina di Pinuccia Montanari
Nata e vissuta a Kharkiv, è guida turistica e traduce testi poetici, Marina ha aderito al viaggio in Ucraina organizzato per il Giubileo della Speranza. Il racconto della sua terra e la speranza di pace
 Venerdi, 17/10/2025 - Marina Sorina, nata e vissuta a Kharkiv dove ha iniziato gli studi universitari, si è trasferita prima in Israele, poi a Verona dove era quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Laureata, ha conseguito un dottorato di ricerca, è guida turistica e traduce testi poetici. Ha partecipato alle missioni del Mean in Ucraina dove il suo ruolo è stato preziosissimo nelle traduzioni, e la sua empatia e sensibilità umana e conoscenza dei luoghi hanno consentito una più profonda relazione con le ucraine e ucraini incontrati.
Venerdi, 17/10/2025 - Marina Sorina, nata e vissuta a Kharkiv dove ha iniziato gli studi universitari, si è trasferita prima in Israele, poi a Verona dove era quando la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Laureata, ha conseguito un dottorato di ricerca, è guida turistica e traduce testi poetici. Ha partecipato alle missioni del Mean in Ucraina dove il suo ruolo è stato preziosissimo nelle traduzioni, e la sua empatia e sensibilità umana e conoscenza dei luoghi hanno consentito una più profonda relazione con le ucraine e ucraini incontrati.Marina, cosa ti ha spinto ad aderire al viaggio in Ucraina organizzato per il Giubileo della Speranza?
Ho deciso di partire perché la prima missione, quella del luglio 2024, è stata un’esperienza molto positiva. Quando ho saputo che saremmo andati proprio nella mia città natale, Kharkiv, non ho avuto dubbi. Sapevo che sarei stata in buona compagnia e che, insieme, avremmo potuto affrontare la realtà ucraina nel modo giusto.
Sei nata a Kharkiv, città simbolo della resistenza ucraina. Cosa puoi raccontarci delle tue origini e del tuo percorso fino a oggi?
Sono nata e cresciuta nel centro di Kharkiv, a pochi passi dall’Università. Ero molto legata al mio quartiere, anche grazie a mia madre, che amava raccontarmi la storia dei palazzi e dei loro dettagli architettonici durante le nostre passeggiate.
Kharkiv ha una storia dolorosa: durante la Seconda guerra mondiale fu occupata due volte dai tedeschi e subì pesanti distruzioni. Forse per questo le palazzine antiche sopravvissute erano per noi ancora più preziose.
Negli anni Novanta ci siamo trasferiti a Oleksiivka, un quartiere verde e tranquillo, ai margini della città. Nel 1994, mentre frequentavo il terzo anno dell’università magistrale, decisi di emigrare in Israele: dopo il crollo dell’Unione Sovietica, le prospettive di lavoro sembravano inesistenti. L’anno successivo, invece, arrivai in Italia, a Verona, dove ho completato gli studi, mi sono laureata, ho conseguito il dottorato di ricerca e ho ottenuto l’abilitazione come guida turistica.
Come immagini si possa affrontare un conflitto come quello in corso? E che futuro vedi per il tuo Paese?
Dopo la vittoria, l’Ucraina potrà diventare uno dei Paesi più attrattivi al mondo, sia economicamente che socialmente. I punti di forza sono evidenti: una natura straordinaria — mari, montagne, steppe, foreste — e città d’arte da scoprire. La società ucraina è dinamica, coesa e al tempo stesso multiculturale e multireligiosa: una ricchezza che la rende vibrante e viva.
Le istituzioni democratiche esistono e funzionano, ma devono essere rafforzate: occorre continuare la lotta alla corruzione e integrare sempre più le nostre leggi e procedure con quelle europee, garantendo trasparenza e controllo del potere.
Sarà poi fondamentale ricostruire l’economia e l’agricoltura, gravemente colpite dalla guerra, e prendersi cura dell’ambiente: la guerra distrugge anche l’ecosistema, e l’Ucraina avrà bisogno di bonifiche, pulizia e ripristino.
A livello umano e sociale, sarà necessario ricucire i legami fra i territori liberi e quelli liberati, e curare le ferite — fisiche e interiori — di chi ha sofferto.
In questo percorso, credo che i Corpi civili di pace potranno avere un ruolo importante: come forza terza, potrebbero aiutare nella sminatura dei boschi o nella riabilitazione dei reduci. La guerra, infatti, anche quando ufficialmente finisce, continua a vivere a lungo nella terra e negli animi, minando la stabilità del dopoguerra.
Alla frontiera abbiamo incontrato molte donne ucraine, spesso sole o con i figli. Qual è la condizione femminile in questa guerra?
Alla frontiera si incontrano due grandi gruppi: le profughe, costrette alla fuga dall’invasione, e le donne della diaspora economica, emigrate anni fa per lavoro. Entrambe restano profondamente legate al loro Paese: tornano per motivi pratici, per rivedere i familiari o per incontrare mariti e figli al fronte.
La guerra ha messo in luce un tratto profondo della società ucraina: la donna come colonna portante. Fin dai tempi antichi, nelle zone di frontiera, le donne gestivano da sole famiglia e fattoria mentre gli uomini combattevano. Anche oggi molte si sono arruolate: circa 70.000 donne, di cui oltre 5.500 in prima linea, come tiratrici scelte o operatrici di droni.
Le altre sostengono l’esercito da casa, come volontarie. In Ucraina il volontariato militare è vitale, perché l’esercito, nel 2022, non si aspettava, un’invasione su larga scala. Amici e parenti si organizzano per fornire ciò che manca: pneumatici, biancheria termica, alimenti.
Le donne più anziane cucinano, fanno conserve, preparano candele per le trincee o intrecciano reti mimetiche.
Oltre al fronte e al volontariato, le donne ucraine guidano imprese, amministrazioni, università, e sostituiscono gli uomini nei lavori rimasti scoperti, dai trasporti alle fabbriche.
Ma la loro forza non le mette al riparo: nelle zone occupate, le donne sono spesso vittime di violenze e soprusi, anche sessuali. Per questo, negli scambi di prigionieri, si dà priorità alle donne. Diverse ONG offrono supporto psicologico e sociale, come “Le madri di Casa Padre Pio” o “Sema Ukraine”, che aiutano le vittime di violenza a ritrovare una vita normale.
Consiglio anche la lettura del libro Le mie donne di Yuliia Iliukha, una raccolta di racconti dedicata alle donne ucraine e alle loro vite durante la guerra.
Come hai vissuto personalmente lo scoppio della guerra nel 2022? Dove ti trovavi e cosa hai provato?
Già dall’autunno del 2021 si percepiva che stava per accadere qualcosa di grave, anche se speravamo fosse solo un atto intimidatorio. Ma a febbraio la minaccia divenne concreta. I nostri amici in Ucraina preparavano borse d’emergenza, sistemavano la casa, si organizzavano per resistere.
Anche a Verona, eravamo in allerta: il 20 febbraio manifestammo in piazza per avvisare la cittadinanza del pericolo.
Nessuno, però, era pronto alla brutalità dell’attacco. All’alba del 24 febbraio mio marito, che aveva seguito la notte intera le notizie, mi svegliò dicendo: “È cominciata l’invasione”. Da quel giorno, per mesi, mi svegliavo sempre a quell’ora, incapace di dormire.
Nei primi mesi mi sono dedicata completamente all’assistenza dei profughi arrivati a Verona: donne con bambini, anziani stanchi e disorientati. Insieme a un gruppo di amiche ci siamo organizzate per accoglierli in stazione, aiutarli con la Protezione Civile e la Questura, accompagnarli nei primi passi di integrazione.
Hai ancora familiari o amici a Kharkiv o in altre zone del Paese? Riesci a mantenere i contatti?
I miei genitori vivono ancora a Kharkiv. Dopo la missione del MEAN, sono rimasta qualche giorno in più proprio per stare con loro. Hanno avuto varie occasioni per espatriare, ma hanno sempre rifiutato: preferiscono restare nella loro città, consapevoli dei rischi. Ci sentiamo spesso e li vado a trovare almeno una volta l’anno.
Negli ultimi anni, anzi, ho rafforzato i legami con molte persone in Ucraina: ex profughe rientrate, amici, poetesse che ho conosciuto traducendo i loro testi. Le loro poesie esprimono in modo profondo il sentire delle donne ucraine. Alcune sono venute in Italia per incontri letterari: così sono nate vere amicizie. A novembre, ad esempio, tornerà Oksana Stomina, che racconterà la sua esperienza durante l’assedio di Mariupol.
Durante questo viaggio, c’è stato un momento particolarmente toccante che porterai con te?
Ce ne sono stati tanti, ma uno mi è rimasto nel cuore.
Il primo giorno a Kyiv, in metropolitana, appena finito un allarme, la gente si accalcava per salire sul treno. Mentre aspettavo, ho notato alcune anziane su una panchina: una teneva un mazzo di margherite, un’altra un cagnolino vivace. Le ho fatto i complimenti, e quando hanno saputo che eravamo una delegazione italiana venuta a pregare per la pace, si sono commosse: “Allora il mondo non si è dimenticato di noi!”.
È stato un momento struggente. La nostra sola presenza regalava loro un sorriso, ma io sentivo tutta la frustrazione di poter fare così poco. In quell’istante ho pensato ancora ai Corpi civili di pace: se fossero già operativi, avremmo potuto indicare loro un luogo dove ricevere aiuto.
Un altro momento intenso è stato a Kharkiv, quando ho improvvisato una piccola visita guidata nel centro storico. Mentre parlavo ai miei compagni dei palazzi dove ero cresciuta, i passanti ci guardavano increduli e sorridevano: un gruppo turistico nel cuore di una città ferita! Sembrava un’immagine del futuro, di una Kharkiv libera e pacifica. Ci siamo sentite come rondini arrivate in anticipo, messaggere della primavera.
Cosa pensi che l’Europa — e in particolare l’Italia — non abbia ancora capito della guerra in Ucraina?
L’Europa vive immersa nel benessere e nella stabilità, e questo spesso la rende poco empatica verso chi sta pagando con sangue e dolore la libertà e la democrazia. Dopo decenni di pace, è difficile immaginare fin dove possa spingersi la disumanità dei regimi totalitari.
Sottovalutare la minaccia russa significa anche non comprendere l’importanza della resistenza ucraina, che oggi difende la sicurezza dell’intero continente.
Molti non hanno ancora capito che l’Ucraina è un Paese indipendente, grande e vitale, con enormi potenzialità. Non è un territorio agricolo marginale, né una “propaggine russa”, come ancora scrivono certi manuali italiani. È il Paese più vasto d’Europa, ricco di risorse naturali e umane, e in molti aspetti più avanzato dell’Italia: pensate alla pulizia delle strade, ai trasporti pubblici gratuiti a Kharkiv, alla rapidità con cui riparano i danni dei bombardamenti.
Proprio questo potenziale dà fastidio alla Russia, che non sopporta di vedere l’Ucraina prosperare con una scelta euroatlantica e democratica.
In fondo, questa guerra è uno scontro fra due civiltà: una proiettata verso il futuro, e l’altra ancorata al passato e alla violenza. Non è solo una contesa territoriale, ma una battaglia tra democrazia e dittatura.
Quando l’Europa capirà davvero quanto è alta la posta in gioco, sono certa che si mobiliterà ancora di più al fianco dell’Ucraina.
Intervista a cura di Pinuccia Montanari
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®










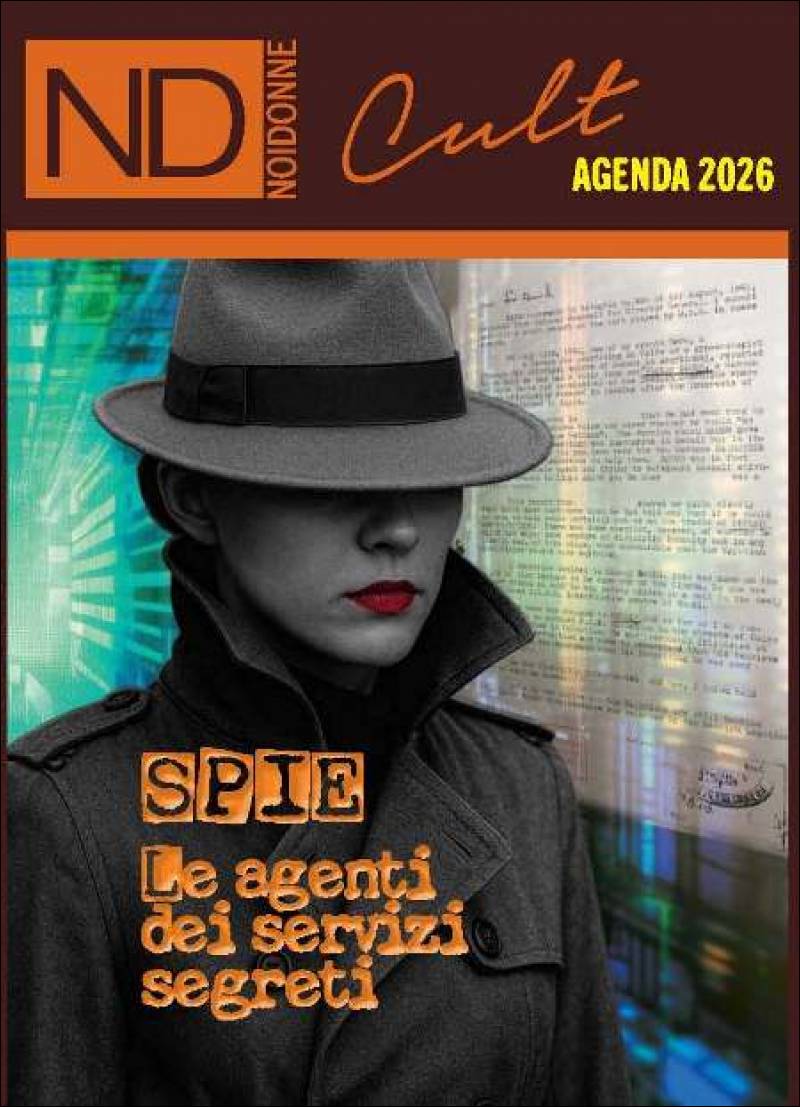
Lascia un Commento