
'L’ideologia gender è pericolosa' di Laura Schettini
Un'attenta ricostruzione storica della presunta 'teoria gender' e un'analisi della campagna antifemminista e antigender
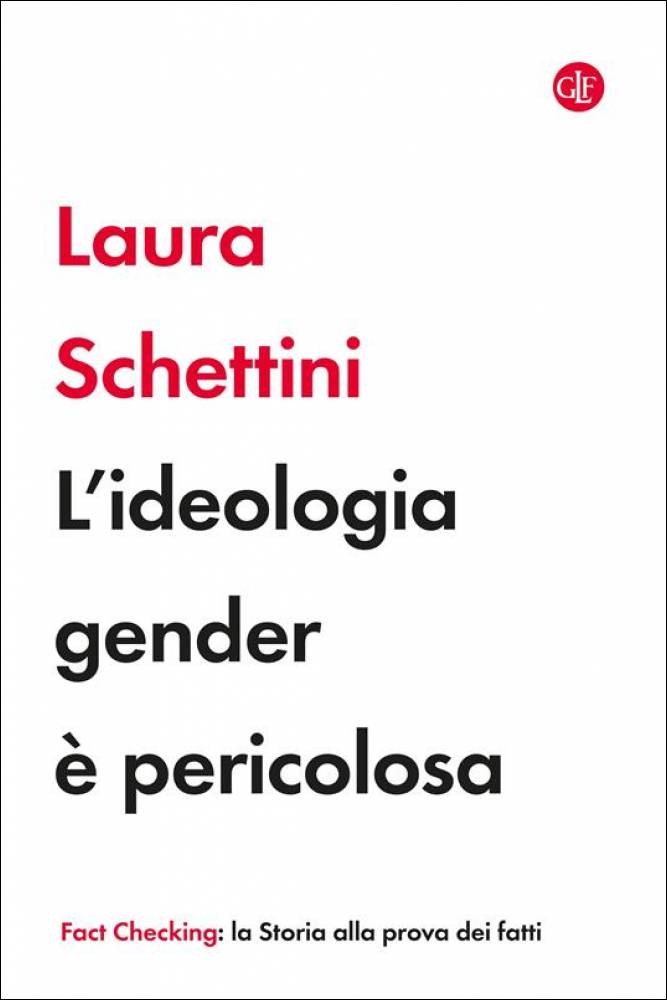 Martedi, 28/10/2025 - Un groviglio con nodi ancora da districare il dibattito che negli ultimi decenni si è sviluppato anche nel nostro paese sulla cosiddetta ‘teoria gender’ o ‘ideologia gender’ o ‘dittatura gender’ insomma su quella che più correttamente può definirsi ‘questione gender’, la questione del genere; ed è forse ovvio che sia così, visto che veniamo da millenni di storia culturale e politica in cui le differenze in base al genere, e non solo quelle, sono rimaste ingabbiate in un ordine gerarchico e contrappositivo, rigidamente binario.
Martedi, 28/10/2025 - Un groviglio con nodi ancora da districare il dibattito che negli ultimi decenni si è sviluppato anche nel nostro paese sulla cosiddetta ‘teoria gender’ o ‘ideologia gender’ o ‘dittatura gender’ insomma su quella che più correttamente può definirsi ‘questione gender’, la questione del genere; ed è forse ovvio che sia così, visto che veniamo da millenni di storia culturale e politica in cui le differenze in base al genere, e non solo quelle, sono rimaste ingabbiate in un ordine gerarchico e contrappositivo, rigidamente binario.Ragionare su questo groviglio da una prospettiva storica è quello che fa il libro “L’ideologia gender è pericolosa” di Laura Schettini, ricercatrice in Storia contemporanea presso l’Università di Padova dove insegna Storia delle donne e di genere.
L’autrice, proprio attraverso l’analisi storica, ricostruisce il processo che ha consentito di mettere al centro del dibattito politico sesso e genere fino a trasformarsi in un conflitto serrato, sfociato in una vera e propria campagna antigender.
Il libro si articola in tre capitoli: il primo parla della vera o presunta esistenza della ‘teoria gender’, il secondo parte dalla critica femminista alla storia per approfondire le ragioni che hanno portato all’introduzione del genere nelle scienze umane e il terzo ricostruisce la storia della campagna antifemminista e antigender prendendo in esame quella ideologia che almeno dalla fine dell’Ottocento ha tentato di imporre una precisa idea di famiglia, di donna, di uomo, di corpi e di sessualità.
Il ragionamento parte da un paradosso: la teoria gender presentata come una minaccia, un pericolo incombente, non riesce ad uscire da una certa nebulosità proprio da parte di chi intende attaccarla.
Si porta come esempio quanto è accaduto in occasione del Ddl Zan presentato nel 2018 alla Camera, approvato e trasmesso al Senato nel 2020 e infine affossato da Lega e Fratelli d’Italia: da un lato un decreto legge che puntava, in nome di una nuova civiltà nelle relazioni umane, sui diritti dei soggetti sessuati in tutte le loro differenze, dall’altro la paura che si volesse mettere in pesante discussione il ruolo educativo della famiglia e incentivare le transizioni da un sesso all’altro.
Giorgia Meloni, allora leader di Fratelli d’Italia, mentre tuonava contro quel decreto che avrebbe a suo dire fatto entrare il gender nelle scuole, alla domanda “cosa è il gender?” aveva candidamente risposto “…io non l’ho mai capito bene”.
Eppure già nel 2015 in occasione della festa della mamma il suo partito aveva affisso manifesti e fatto volantinaggi davanti alle scuole contro una presunta “dittatura gender”.
Era stata in verità per prima la Chiesa nel 1994, in preparazione della Conferenza di Pechino, a manifestare ostilità al termine gender addossandone la responsabilità ai femminismi che, smantellando lo stereotipo femminile tradizionale, attaccavano la famiglia e parlavano di diritti riproduttivi e libertà di scelta. Proprio a Pechino nel ‘95 una donna ultracattolica e militante pro-life e pro-family, Dale ‘OLeary, aveva presentato un testo di trenta pagine in cui distingueva tra femminismo dell’equità che riconosce l’uguaglianza morale e giuridica dei sessi -con le loro differenze naturali da cui necessariamente deriverebbero precisi ruoli e compiti sociali- e gender femminismo che a partire dagli anni Sessanta portava avanti un attacco alla famiglia e alla missione materna, promuovendo omosessualità e aborto. Una famiglia solida, concludeva, è la migliore protezione per le donne, affermazione clamorosamente smentita in questi ultimi trenta anni dai tanti femminicidi e violenze in ambito domestico.
Lo sguardo attento di Laura Schettini si sposta poi agli inizi del nuovo millennio quando i movimenti nazionalisti e familisti affermatisi in Europa e in America, in perfetta sintonia con il cattolicesimo tradizionalista, attaccano il femminismo e difendono a spada tratta la famiglia ‘naturale’. Dopo il 2010, con l’emergere di nuove soggettività, vengono ad essere presi di mira soprattutto quei gruppi di pressione, come le lobby gay e il movimento lgbt+, che sostengono la fluidità di genere, accusati di eliminare la differenza sessuale e di spingere le donne verso la mascolinità. Attacchi in questo senso arrivano anche da parte del femminismo della differenza, quello legato alla Libreria delle donne di Milano, a difesa del primato materno e molto critico verso alcuni esiti della neolingua, accusata di voler eliminare del tutto la differenza femminile e addirittura la parola donna.
La neolingua, quel processo avviato dai primi anni Ottanta dal femminismo per denunciare e smantellare il sessismo presente nella lingua italiana, diviene così nuovo terreno di scontro. Per quelle della mia generazione è stato un punto di svolta fondamentale prendere piena coscienza del nascondimento inferiorizzante del soggetto donna nel linguaggio parlato e scritto (come accade nell’uso del maschile sovraesteso) e della misoginia nei significati e nelle definizioni del femminile.
Nel libro viene giustamente ricordato il lavoro prezioso di Alma Sabatini che nel 1986, per conto della Commissione per la parità tra uomo e donna istituita dal Consiglio dei ministri due anni prima, curò le 'Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana' al fine di “dare visibilità linguistica alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti alle donne”. Questa sperimentazione linguistica in chiave non sessista non è ancora conclusa, stretta tra innovazioni, ripensamenti e resistenze, come si evince dalla lettura di alcune pagine di questo libro.
Come scrive Laura Schettini, la parola ‘genere’ ha una sua storia che va conosciuta e lei ce la racconta nel secondo capitolo e ci spiega come quel termine, diventato una precisa chiave di lettura femminista, sia apparso ben prima della cosiddetta teoria gender. Per dimostrarlo si sofferma sul lungo percorso che le donne hanno fatto per entrare da protagoniste nella polis e fa riferimento al lavoro di ricerca di storiche come Franca Pieroni Bortolotti, Anna Bravo, Annarita Buttafuoco, Angela Groppi, solo per citarne alcune che per prime hanno restituito presenza storica e senso alle loro simili, al loro sesso, infine al loro genere.
Il genere viene infatti introdotto solo in un secondo momento in ambito storico, sollecitato dalle donne del movimento e dai loro centri di documentazione.
Ricordo che in Italia il termine genere è entrato nelle teorie politiche e nelle pratiche discorsive del femminismo, Udi compresa, negli anni Ottanta per la necessità di distinguere tra sesso come dato biologico, naturale, e genere come struttura ideologica, costrutto culturale patriarcale dunque misogino, da interrogare e decostruire in nome della libertà e autenticità dei soggetti: questo è il significato e la funzione che noi donne abbiamo dato e diamo al termine genere, mettendo nello stesso tempo a nudo anche il costrutto culturale della mascolinità e la sua pericolosità.
Di grande interesse è il ragionamento che l’autrice fa nel restituirci i motivi del passaggio da una storia delle donne riparativa, in cui le donne vengono studiate come gruppo a sé a cui restituire valore, ad una storia di genere più attenta alle differenze tra donne e alle dinamiche del potere e della subordinazione, che prende in considerazione anche l’altro genere e altre forme di assoggettamento (classe, razza, …) in un’ottica intersezionale. Lo studio delle donne come sfere separate non sembrava sufficiente a restituire nella sua complessità l’esperienza femminile e a cambiare radicalmente le narrazioni storiche dominanti. Assumere il genere come categoria di analisi privilegiata non significa affatto, come alcune temono, la fine della differenza sessuale poiché “la storia di genere ha la funzione di raccontare e interpretare i significati attribuiti alla differenza sessuale nel corso del tempo, svelarne il carattere artificioso e politico, portare alla luce le relazioni di potere…”.
La prospettiva storica, dice Laura Schettini senza mai perdere il tono pacato del suo ragionare, consente di far emergere nelle varie epoche, e molto prima del ‘900, le tracce dell’esistenza di amori omosessuali, corpi ambigui e loro correzioni chirurgiche, travestitismi, cambi di genere e varie forme di famiglia a dimostrazione che quella ‘naturale’ non è l’unica famiglia possibile.
Di tutto questo parla nel terzo capitolo prendendo in considerazione soprattutto il femminismo delle origini compresi gli anni d’oro del suffragismo (1906-1911), il Risorgimento, il colonialismo, il lavoro, la Resistenza. Sono gli anni che videro la nascita e il consolidarsi dello Stato unitario fondato sulla disparità dei poteri tra i sessi e la rigidità dei ruoli tradizionali. Viene sottolineato il carattere discriminatorio ed oppressivo del codice civile: la famiglia ‘naturale’ con al centro in posizione dominante la figura del padre padrone, l’autorizzazione maritale (fino al 1919), l’esclusione delle donne dalla cittadinanza, le limitazioni nell’accesso all’istruzione e al lavoro, la sperequazione salariale.
Alla domanda finale, se cioè la teoria gender sia un pericolo, l’autrice risponde che lo è, si augura che lo sia, ma solo se per genere si intende quello che “in molteplici forme e per bocca di diversi soggetti rivendica la legittimità di vari modi di fare famiglia, di essere e sentirsi uomini e donne, di essere intersessuali o trans” in raccordo pieno con la formulazione originaria, quella cioè introdotta e teorizzata dal femminismo. Pericoloso dunque sì, ma per le strutture materiali e simboliche del patriarcato.
Laura Schettini
L’ideologia gender è pericolosa
Editori Laterza 2023
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

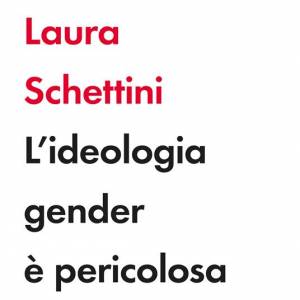


Lascia un Commento