
LEADERSHIP FEMMINISTA E DIMENSIONE COLLETTIVA PER PRODURRE CAMBIAMENTI
Conversazione con Giovanna Badalassi sulle incertezze del momento, le prospettive per l’occupazione femminile anche in vista dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Le previsioni di un futuro che deve trovarci preparate
“Il momento che stiamo attraversando è molto confuso e parecchio difficile su tutti i livelli, e le questioni di genere, essendo parte del mondo, risentono della crisi geopolitica”. Interpelliamo Giovanna Badalassi – ricercatrice ed esperta di bilanci di genere, fondatrice di www.ladynomics.it – sulle prospettive dell’economia nel suo complesso e, in particolare, sul lavoro. “A questo disorientamento generale si aggiunge, per noi donne, anche la necessità di una riflessione complessiva su dove vogliamo andare, consapevoli che oggi molte questioni di parità sono state superate o, per lo meno, sono in via di risoluzione. Penso alle progressioni nelle carriere, agli ostacoli nelle professioni oppure agli importanti inquadramenti normativi ottenuti. Se solo pensiamo alle tante donne leader che abbiamo oggi, dalla Presidente della Commissione Europea alla Presidente della BCE fino, in Italia, alla prima Presidente del Consiglio e alla Segretaria del maggiore partito di opposizione, vediamo una situazione inimmaginabile solo qualche anno fa. È chiaro, quindi, che, con tanti ‘soffitti di cristallo’ infranti, o che si stanno per infrangere, bisogna individuare altri obiettivi di parità, ponendosi la questione sul ‘cosa fare’ oltre che sul ‘chi lo deve fare’”.
La questione, effettivamente, appare centrale poiché ci rendiamo conto che troppo spesso le donne arrivate ai vertici non ‘fanno la differenza’ e secondo Badalassi lo snodo odierno è che “i cambiamenti riescono solo se si ritorna alla dimensione collettiva del femminismo, perché il grande equivoco di questi anni è stato pensare che, per risolvere i problemi, sarebbe bastato avere più donne che facessero carriera. Ora stiamo invece cominciando a capire che avere più donne nei posti di potere è una condizione certamente necessaria, ma non sufficiente per cambiare le regole generali e per modificare l’organizzazione di sistema e di struttura”.
.jpg) Cosa significa ‘tornare alla dimensione collettiva del femminismo’?
Cosa significa ‘tornare alla dimensione collettiva del femminismo’?
“Se le donne per fare carriera individualmente si devono appoggiare a chi le sostiene nell’ascesa delle gerarchie, soprattutto uomini, una volta arrivate non possono avere da sole la forza per poter cambiare il sistema, finendo così con il perpetuare le regole di chi le ha sostenute. Per sottrarsi a questo circolo vizioso occorre una leadership femminista (non solo femminile) che è tale perché può contare sulla spinta dal basso, da quella collettività di donne che chiedono un avanzamento e vogliono cambiamenti in questa direzione”.
Puoi fare qualche esempio virtuoso?
“Negli Enti Locali ho già incontrato alcuni casi virtuosi di elette che riescono a ottenere risultati grazie anche alla forza di un elettorato femminile che permette loro di essere più indipendenti nella loro azione politica. In generale, le regioni che hanno un maggiore empowerment femminile sono le stesse che hanno anche più donne nelle amministrazioni locali. È quindi un circuito virtuoso che si autoalimenta, perché avere molte donne implica una maggiore forza democratica, una maggiore cittadinanza femminile. Per esercitare una forza di cambiamento le elette non possono quindi essere cooptate dagli uomini ma devono avere un mandato da una propria forza elettorale alla quale rendere conto. Dobbiamo fare il salto verso una dimensione collettiva, come quella che c'era negli anni ’70 e che negli anni ‘80 abbiamo perduto per una dinamica storica, economica, sociale e occupazionale. Adesso va recuperata, anche se con modalità e obiettivi differenti, poiché i tempi sono ovviamente diversi”.
Purtroppo la quotidianità non appare rassicurante…
“Non sono così pessimista, penso che il peggio sia passato; i continui polveroni e colpi di scena hanno raggiunto secondo me un picco che non potrà andare oltre o comunque durare molto a lungo. Almeno, quel senso di paralisi che abbiamo avvertito nei mesi scorsi si sta un po’ sciogliendo e si sta cominciando, anche se molto timidamente, a reagire”.
Hai segnali in tal senso?
“Sì, vedo movimenti nei territori, gruppi piccoli che si stanno orientando già verso l’innovazione sociale, ma dovranno aggregarsi e rafforzarsi molto di più, ovviamente, per riuscire a conquistare una rappresentazione mediatica mainstream”.
Rispetto al lavoro per le donne, quale è la fotografia che ci consegni oggi?
“Le criticità strutturali dell’occupazione femminile in Italia le conosciamo ormai molto bene: precarietà, gender pay gap, part-time involontario, segregazione orizzontale, motherhood penalty, disuguaglianze territoriali ecc. Il recente aumento del tasso di occupazione femminile non riesce però a nascondere, nei numeri ma anche nell’esperienza di tutte, che si tratta di lavoro povero sia dal punto di vista economico che professionale. Se ne esce, quindi, solo con una strategia di sistema che sappia leggere queste dinamiche all’interno di un più ampio contesto di scelte di sviluppo economico e di investimenti: spendere nelle strutture per i servizi sociali oppure in autostrade o ponti non è indifferente per il lavoro delle donne”.
Come Ladynomics avete molto chiaro questo approccio, che però non sembra attraversare il discorso pubblico.
.jpg) “È vero, ma stiamo anche vivendo in un ciclo storico particolarmente carico di tensioni geopolitiche che ci obbligheranno ad investire nella difesa e nella tecnologia che la supporta. Probabilmente in futuro si riuscirà a trarre da questi investimenti anche qualche beneficio a favore dell’innovazione, come è successo ad esempio per internet, che inizialmente era un progetto strategico militare. Si tratta dunque di scelte di investimento dettate, certo, dalla contingenza, che però rischiano di penalizzare particolarmente il lavoro femminile nel breve termine, dato che in questi settori lavorano pochissime donne. Inoltre si corre un rischio serio di vedere ridotti i livelli di welfare, che invece è un ambito particolarmente gender sensitive sia per l’utenza diretta e indiretta (pensiamo alle donne caregiver) sia per l’impatto occupazionale delle donne in questi settori. Queste scelte di investimento favoriranno quindi più gli uomini nel breve termine, poiché sono molto più presenti in settori come la tecnologia, la manifattura, le costruzioni, l’edilizia, dove invece la presenza femminile, anche se in crescita, è pur sempre piuttosto limitata. Per fare un esempio molto concreto, pensiamo al bonus edilizio: con 110 miliardi nel settore dell’edilizia l’effetto per le donne a breve termine è stato molto sbilanciato, non solo per l’occupazione diretta ma anche per gli investimenti accessori che si rendono necessari (ad esempio un’acciaieria avrà bisogno di strade o ferrovie, cioè di nuovo investimenti concentrati sull’occupazione maschile). Le politiche per il lavoro non dovrebbero quindi mai ragionare solo sul breve termine. Purtroppo come collettività manca, soprattutto a noi donne, la capacità di guardare più lontano verso le grandi decisioni di sviluppo economico. Eppure il legame tra diversificazione produttiva di un territorio ed empowerment femminile è piuttosto chiaro, basta osservare le regioni nelle quali c’è il tasso di occupazione femminile più alto: sono le stesse che hanno un elevato tasso di sviluppo in generale e anche un'elevatissima diversificazione delle attività economiche, sia nell’industria che nei servizi”.
“È vero, ma stiamo anche vivendo in un ciclo storico particolarmente carico di tensioni geopolitiche che ci obbligheranno ad investire nella difesa e nella tecnologia che la supporta. Probabilmente in futuro si riuscirà a trarre da questi investimenti anche qualche beneficio a favore dell’innovazione, come è successo ad esempio per internet, che inizialmente era un progetto strategico militare. Si tratta dunque di scelte di investimento dettate, certo, dalla contingenza, che però rischiano di penalizzare particolarmente il lavoro femminile nel breve termine, dato che in questi settori lavorano pochissime donne. Inoltre si corre un rischio serio di vedere ridotti i livelli di welfare, che invece è un ambito particolarmente gender sensitive sia per l’utenza diretta e indiretta (pensiamo alle donne caregiver) sia per l’impatto occupazionale delle donne in questi settori. Queste scelte di investimento favoriranno quindi più gli uomini nel breve termine, poiché sono molto più presenti in settori come la tecnologia, la manifattura, le costruzioni, l’edilizia, dove invece la presenza femminile, anche se in crescita, è pur sempre piuttosto limitata. Per fare un esempio molto concreto, pensiamo al bonus edilizio: con 110 miliardi nel settore dell’edilizia l’effetto per le donne a breve termine è stato molto sbilanciato, non solo per l’occupazione diretta ma anche per gli investimenti accessori che si rendono necessari (ad esempio un’acciaieria avrà bisogno di strade o ferrovie, cioè di nuovo investimenti concentrati sull’occupazione maschile). Le politiche per il lavoro non dovrebbero quindi mai ragionare solo sul breve termine. Purtroppo come collettività manca, soprattutto a noi donne, la capacità di guardare più lontano verso le grandi decisioni di sviluppo economico. Eppure il legame tra diversificazione produttiva di un territorio ed empowerment femminile è piuttosto chiaro, basta osservare le regioni nelle quali c’è il tasso di occupazione femminile più alto: sono le stesse che hanno un elevato tasso di sviluppo in generale e anche un'elevatissima diversificazione delle attività economiche, sia nell’industria che nei servizi”.
Servirebbe, quindi, più razionalità e un’ottica strategica.
“Ci manca anche il posto dove ragionarne insieme. Se parliamo di questi argomenti sui social siamo immediatamente punite dagli algoritmi che privilegiano un approccio emotivo ed emergenziale, con il risultato che questo tipo di prospettiva rimane limitata a piccoli contesti e occasioni pubbliche specialistiche ma non può essere condivisa con un pubblico più ampio”.
Va detto che neppure l’associazionismo femminile è esente da questo approccio.
“Negli anni l’associazionismo si è venuto a frammentare in una miriade di iniziative parcellizzate, molto spesso sostenute e guidate da personalità femminili che finivano quasi con identificarsi con la causa. Oggi le nuove e ben più forti sfide che abbiamo davanti richiedono di superare questo approccio cercando di aggregare un consenso intorno ai contenuti più che attorno alle persone o ai gruppi identitari. Abbiamo anche bisogno di un movimento di donne con competenze che possa elaborare proposte politiche di qualità e corali, frutto di visioni a lungo termine”.
Tutto questo, al momento, lo vedi possibile?
“In questo momento no. Certo, ci sono piccole bolle di esperte ma non c’è una strategia condivisa né una piattaforma comune sulla quale confrontarsi. Ma la possiamo costruire. Nel nostro libro (Signora Economia, ndr) parliamo delle esperienze nei paesi nordici, dove hanno sperimentato la strategia dei Velvet Triangle creando delle reti di collaborazione sui tre poli: il mondo produttivo, il mondo pubblico e il terzo settore. Questo ha permesso loro di avere diverse presidenti del Consiglio sostenute anche da un elettorato femminile che dava loro un mandato di cambiamento. Prima di arrivare a questo punto in Italia abbiamo bisogno però di ricostruire una postura relazionale, una capacità di comportamento e di riconoscimento reciproco in cui ci si valorizza a vicenda per le proprie specialità. Ci sono certamente donne dalle professionalità e competenze eccezionali in tutti i campi, ma non c’è un comune terreno di confronto che permetta loro di mettere le proprie capacità a fattore comune. Mancando questo, ci si ferma al riconoscimento delle singole carriere. Se però non si riesce a orientare queste competenze al benessere comune e ad una ricaduta favorevole per tutta la società, queste donne di successo rischiano non solo di rimanere ininfluenti, ma anche di demotivare le altre, molte, donne che in questi anni si sono battute per una leadership femminile: perché continuare a impegnarsi su questo fronte se poi non si coglie la differenza nei risultati per la collettività, ma solo per le dirette interessate?”. Per superare questa dimensione individualista dell’empowerment femminile abbiamo bisogno di una visione forte che sostenga però programmi, progetti e iniziative molto concrete, perché sui discorsi intorno ai massimi sistemi che si fermano al ‘ci vorrebbe’ direi che in questi anni abbiamo già dato”.
Se è vero che siamo ad un tornante della Storia, certamente è questo il momento di esserci con un pensiero effettivamente diverso, mettendo in gioco saperi importanti che non avevamo 30, 40 anni fa. A proposito di futuro, che impatto ha l’Intelligenza Artificiale da un punto di vista di genere?
“Sull'intelligenza artificiale si è detto tutto e il suo contrario. Di sicuro è un'altra rivoluzione tecnologica. Guardando le precedenti rivoluzioni possiamo già prevederne il percorso e i passaggi, quello che però non conosciamo sono i tempi e l’intensità. Sappiamo che l'AI distruggerà posti di lavoro soprattutto nei servizi, un po' meno nella parte manifatturiera industriale, perché è già stata molto automatizzata. A rischio sono i lavori dei cosiddetti ‘colletti bianchi’ e i mestieri ripetitivi di qualifica medio-bassa, attività che in gran parte riguardano le donne. Difficilmente saranno invece coinvolti i lavori nei servizi alla persona, dove c'è la cura e una corporeità da gestire. È vero che l’AI creerà nuovi posti di lavoro, ma penso che almeno all'inizio saranno molti meno rispetto a quelli che distruggerà. Saranno, inoltre, impieghi tecnologicamente molto complessi che riguarderanno prevalentemente gli uomini. Inoltre, anche se siamo solo agli inizi, stanno già emergendo criticità di diverso tipo dal punto di vista della parità di genere: l’AI, scritta soprattutto da uomini, riproduce tutti i possibili gender bias presenti nella nostra società. Forse anche per questo motivo, le donne la stanno usando di meno, alimentando così un ulteriore ritardo nello sviluppo delle proprie competenze in materia. Come in tutte le rivoluzioni tecnologiche, sappiamo poi che l’obiettivo primario dell'AI è il profitto, che presumibilmente verrà perseguito esattamente come in tutte le precedenti rivoluzioni tecnologiche. Possiamo già ipotizzare che ci sarà un periodo iniziale ‘corsaro’, senza regole, che praticamente è quello che già stiamo vivendo. Poi si arriverà a un costo sociale talmente elevato da provocare reazioni collettive che costringeranno i governi a regolamentare l’AI per attutirne l’impatto sulla vita e il benessere delle persone. Alla fine del percorso potremo magari assistere persino a risvolti positivi per la parità di genere, come è successo dopo la rivoluzione industriale per il diritto di voto e i diritti del lavoro ed economici delle donne, però bisogna passare attraverso un processo di instabilità sociale molto forte. Sarà un lungo e faticosissimo percorso nel quale le donne ‘più forti’ si salveranno, le donne più fragili si perderanno e, lo dico con enorme consapevolezza e dolore, le donne nel mezzo dovranno combattere duramente per non soccombere socialmente ed economicamente”.
Che intendi per donne ‘più forti’?
“Non mi riferisco solo alla forza economica, ma anche, e forse soprattutto, a quella relazionale, che consente di superare le avversità. Guardando al passato, le donne sono diventate più forti solo attraverso battaglie collettive che, certamente, hanno poi aperto la strada anche a successi personali. Crisi così profonde come quelle che stiamo vivendo – e quelle che arriveranno – si superano solo investendo in una dimensione collettiva capace di alimentare la ricchezza relazionale. Non mi riferisco soltanto alle forme di mutuo aiuto, che pure sono preziosissime, ma alla costruzione di reti di relazioni che permettano di accedere a opportunità che lo Stato non sempre è in grado di offrire a chi non proviene da contesti abbienti. Anche in questo caso, dunque, è fondamentale uscire dall’isolamento e costruire un approccio di comunità, di prossimità. Stare vicine, insieme come donne, rappresenta il più forte antidoto contro la povertà culturale ed economica”.
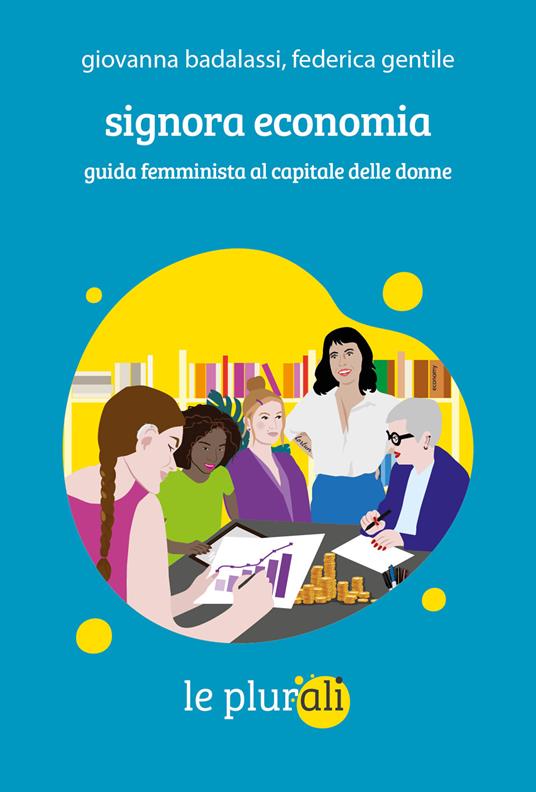 GIOVANNA BADALASSI
GIOVANNA BADALASSI
Economista di formazione, è ricercatrice, consulente e formatrice con una lunga esperienza nelle strategie di gender mainstreaming. Pioniera del Gender Budgeting a livello locale in Italia, dal 2003 ha lavorato a circa quaranta progetti di Bilancio di genere presso Comuni, Province e Regioni. Attualmente, nell'ambito di un progetto della Commissione Europea, supporta il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano nella redazione del Rapporto nazionale di Gender Budgeting (2024–in corso), dopo averlo fatto per i corrispondenti Ministeri della Grecia e del Portogallo. Negli ultimi quattro anni è stata anche formatrice per l’European University Institute a Bruxelles, dove ha svolto corsi di formazione per la DG Budget della Commissione Europea sull’integrazione della dimensione di genere nel bilancio UE. È cofondatrice insieme a Federica Gentile di www.ladynomics.it, un blog attivo da dieci anni sui temi di economia e bilancio di genere. Insieme hanno pubblicato ‘Signora economia. Guida femminista al capitale delle donne’ (Le Plurali, 2024), un saggio “agile e ricco di dati e analisi aggiornati, apre lo sguardo al contributo delle donne all’economia mondiale. Dalla segregazione spaziale al valore sommerso del lavoro di cura, dall’impatto del cambiamento climatico sulla povertà delle donne al maschilismo dell’austerity: questa bussola invita ad analizzare il presente e a immaginare una nuova economia femminista, al servizio delle persone e non al loro comando”.
Questo articolo è parte del progetto ‘Pratiche di cittadinanza in dialogo con il futuro’ dell’Associazione NOIDONNE TrePuntoZero sostenuto con i fondi dell'8xMille della Chiesa Valdese. Tutti i materiali del progetto sono raccolti qui
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®



Lascia un Commento